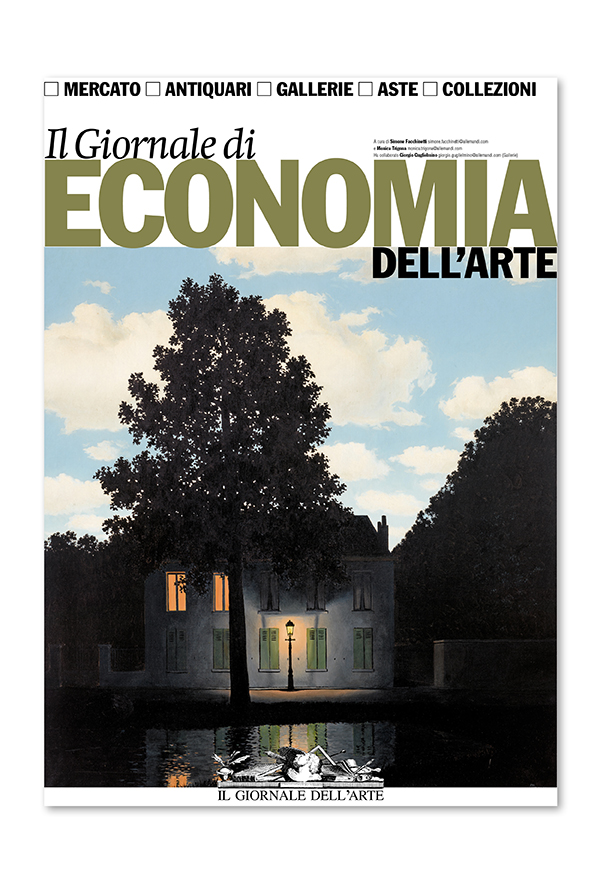La massima secondo cui «il tutto è maggiore della somma delle sue parti» si adatta perfettamente alle installazioni selvagge ed entropiche dell’artista statunitense Sarah Sze (Boston, 1969). Il «tutto» in questione eleva le sue parti necessarie trovando la magia nel banale, prendendo oggetti di uso quotidiano e intrecciandoli in un commento sul bisogno umano di dare un senso a un mondo fuori controllo. Sze è emersa sulla scena artistica americana all’inizio degli anni Duemila con un rapido successo, diplomandosi alla School of Visual Arts di New York prima di ricevere una borsa di studio MacArthur «genius» nel 2003 e di rappresentare gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia un decennio dopo.
Le vorticose ecologie di Sze sono visibili fino al 10 settembre nella sua mostra personale «Timelapse», che occupa sia gli spazi interni sia la facciata del Solomon R. Guggenheim Museum di New York. Un altro intervento realizzato appositamente sarà inaugurato il 19 maggio in una sala d’attesa abbandonata da tempo sopra la stazione ferroviaria londinese di Peckham Rye. Cocommissionata dall’organizzazione artistica britannica Artangel, fino al 16 settembre «The Old Waiting Room» occuperà uno spazio a volta sopra la biglietteria principale della stazione, una stanza che è stata chiusa negli ultimi 50 anni.
Il Guggenheim è dal punto di vista architettonico unico, con le sue pareti circolari e la rampa a spirale che sale nell’atrio centrale. Può parlarci delle difficoltà che ha incontrato nella gestione dello spazio e di come questo abbia influito sulle sue scelte?
All’interno del Guggenheim ogni singola decisione riguarda ogni centimetro del museo, perché ogni centimetro cambia. I piani hanno angolazioni diverse. In ogni campata, ogni singola misura è diversa. È uno degli edifici più radicali mai costruiti. Inoltre, c’è questo enorme vuoto che modifica l’intera percezione dello spazio. Quindi, anche se si occupa un pezzo dell’architettura, non si può avere la sensazione di essere in quello spazio. Ho pensato a ciascuna campata della passerella centrale come a una sorta di creatore di immagini, e ognuna di esse produce immagini in modi diversi.
Così, un dipinto potrà essere un video,una scultura; o una scultura potrà essere un video, un dipinto; e si fondono e diventano una cosa sola, e si separano e diventano tre davanti ai vostri occhi in ogni campata in modi diversi. È stato molto gratificante e interessante vedere come la gente entra: ci sono persone sedute per terra, ci sono bambini radunati davanti ai «Timekeepers». Dopo due inaugurazioni, dieci giorni di apertura al pubblico e 15mila persone nei fine settimana, non è stato rotto nulla.
Il comportamento del pubblico nello spazio è totalmente diverso. Il capo della sicurezza mi ha detto: «Lavoro qui da 20 anni e non ho mai visto questo tipo di coinvolgimento con le opere d’arte». Di solito le persone si muovono sulla rampa del museo a una certa velocità, ma questa velocità è stata rallentata in modo esponenziale nella mostra.
È solita eseguire schizzi? Come procede quando inizia ad assemblare un pezzo?
Seguo un metodo di disegno che in realtà si basa più sulla mia formazione architettonica, che è più astratto: linee sciolte che mostrano la cadenza della composizione complessiva e del suo funzionamento, la coreografia di dove ci si può muovere velocemente, o lentamente.
Per «Timelapse» volevo che le transizioni fossero molto coreografiche. Una volta che ci si rende conto di ciò che sta accadendo alla propria arte nello spazio, il confondersi dell’arte con la vita, dell’architettura con l’opera d’arte, della luce con l’oscurità, avviene in modo naturale attraverso il movimento del corpo e del tempo.
Parlando del suo background architettonico, in termini di gesto e luce, come interagirà il suo lavoro con la sala dʼattesa «dimenticata» di Peckham Rye?
È uno spazio folle, sorprendente, davvero emozionante. So che è stata costruita nel 1865 e che non è stata aperta al pubblico dal 1962. Mi è stato detto che quando il Crystal Palace è stato costruito, ci si aspettava che, dato che ci sarebbero state molte persone che volevano andarci, questa sala d’attesa sarebbe stata davvero necessaria, ma è stato un errore di calcolo sull’effettiva necessità. Poi ha attraversato diverse fasi. Per un po’ è stata una sala da biliardo. E poi semplicemente non ne avevano bisogno. Così è stata letteralmente sbarrata, in parte cementata, e se ne stava lì, nascosta in bella vista. Così i treni passano su entrambi i lati, ma c’è questa capsula del tempo nel bel mezzo della vita contemporanea.
Non voglio rivelare troppo, ma mi piace molto l’idea della sala d’attesa o dell’attesa di un treno. Questa tensione è sempre stata interessante per me. Mi interessa giocare con la nostalgia del fatto che questo sarebbe stato un posto grandioso, e ora invece è piuttosto decrepito, ma in modo bellissimo: il senso di grandezza, perso o riconquistato, ma reinventato. Questo tipo di esperienza magica è la sensazione che si prova quando si va lassù. Mi interessa che il lavoro dia la sensazione di essere ancora vivo. Ha un senso di performance dal vivo, di jazz dal vivo, di danza dal vivo, di tutte queste cose. E quando ci si avvicina, si ha la sensazione che possa accadere qualcosa in quel momento, che se si rimanesse un’altra ora sarebbe un’opera diversa.
Ci si sente come se si entrasse in questo spazio dimenticato, ma poi si avverte una sensazione completamente viva di un arrivo vivo nello spazio, un nuovo arrivo, un nuovo modo di usare quello spazio. Pensavo alla stazione e alla sala d’attesa come a luoghi. L’aeroporto LaGuardia di New York è stata una commissione molto interessante per me, perché in un aeroporto, sia che si arrivi sia che si parta, si vive un momento di grande attesa per ciò che verrà. Anche la sala d’attesa rappresenta l’idea dell’attesa di qualcosa: si è immersi in questo momento di attesa. Credo che nei miei lavori io abbia sempre cercato di trovare un punto in cui ci si trovi in bilico tra l’andare e il venire, tra il crescere e il morire, tra lʼentropia e la crescita, e si sia in una sorta di punto di svolta, si sia su una corda tesa che va da una parte o dall’altra.
Come si procura tutti questi pezzi, visto che ci sono così tante parti in movimento?
Una delle cose che mi interessano è l’idea di come un’immagine si genera o si autogenera, e di come generiamo le immagini oggi. Il concetto di autore è discutibile, così come quello di proprietà. L’immagine è in competizione con l’oggetto, se non addirittura lo sostituisce, in termini di modi in cui ci esprimiamo e comunichiamo attraverso cose non viventi.
Credo che nel lavoro stesso e in ogni mostra mi interessi far vedere allo spettatore che l’opera si sta generando davanti ai suoi occhi. E questo ha anche a che fare con la visione degli strumenti utilizzati. La scultura stessa è lo strumento. Nella commissione Artangel, tutte le videocamere sono nella scultura. Quindi la scultura è sia la scultura sia lo strumento. E ancora oggi pensavo: «Come possiamo renderla anche un dipinto?». Il mio lavoro si autoalimenta in qualche misura, ma l’origine è il mondo. La maggior parte delle immagini, ad esempio, proviene dal mio iPhone.
Ma il 10% non lo è ed è un 10% importante, perché mi interessa l’idea che se vuoi comprare una foto di un vulcano, puoi comprarla proprio come puoi comprare un pennello; è tua e la possiedi, e questo è qualcosa di relativamente nuovo. Il commercio di immagini, il possesso di immagini, lo scambio di immagini, in realtà esiste da molto tempo, ma ora viene utilizzato ogni giorno in un modo mai visto prima. Così, come le immagini, è possibile procurarsi oggetti ovunque in un modo che è davvero particolare.

Un ritratto di Sarah Sze. © Deborah Feingold

Una veduta dell’allestimento della mostra di Sarah Sze al Guggenheim. Foto: David Heald. © Solomon R. Guggenheim Foundation