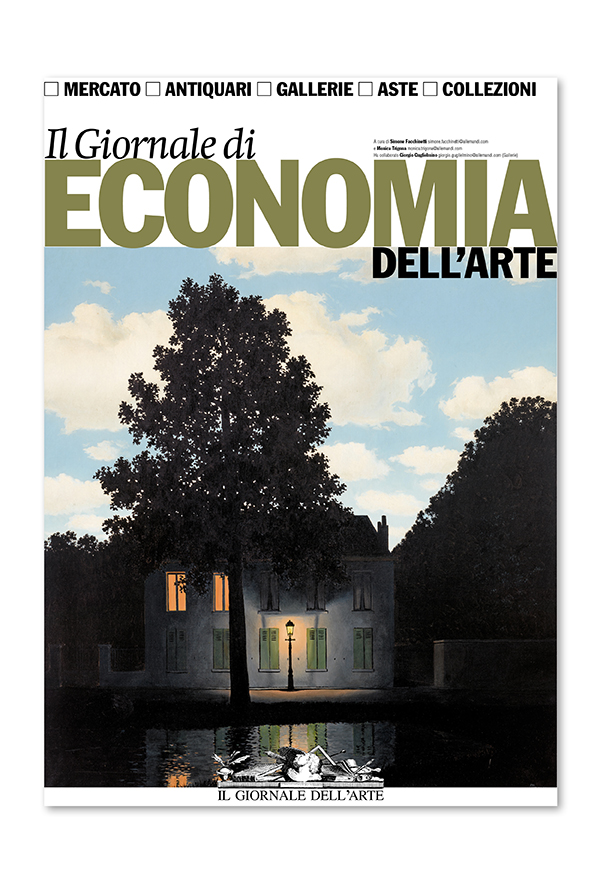Femminista prima ancora del femminismo, militante contro gli stereotipi di genere e al tempo stesso orgogliosamente femminile e sensuale, attivista nella lotta contro il razzismo e innamorata delle culture più diverse e lontane, Niki de Saint Phalle (Neuilly-sur-Seine, 1930-La Jolla, 2002, franco-americana) è protagonista al Mudec, dal 5 ottobre al 16 febbraio 2025, di una monografica prodotta da 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore con Fondazione Deloitte e curata (con Niki Charitable Art Foundation) da Lucia Pesapane, cocuratrice, anche, della mostra del marito Jean Tinguely in Pirelli HangarBicocca.
Convinta com’era che ingiustizie e diseguaglianze potessero essere sanate (anche) da un’arte gioiosa e inclusiva, Niki de Saint Phalle ha declinato la sua aspirazione alla libertà e ai diritti condivisi in sculture arcinote come le «Nanas», potenti matriarche orgogliosamente curvy e danzanti, ma anche in tante altre opere meno note. Il Mudec ne espone 110, una decina delle quali monumentali (si dedicò anche all’arte pubblica), oltre a lavori su carta, video e abiti di Dior: lei, che era stata modella, viveva l’abbigliamento come un mezzo di affermazione del femminile.
Il percorso, in otto tappe, affronta per intero il suo immaginario, dagli «Spari (Tirs)», con cui agli esordi faceva esplodere con una carabina sacchi di colore, alle prostitute, streghe, spose, madri, dee, dei primi anni ’60 (figure femminili ingabbiate nei ruoli inflitti dalla cultura del tempo); dalle potenti «Nanas» (molte nere) alle opere monumentali del «Giardino dei Tarocchi» di Capalbio; dalle «Madri divoratrici» dei ’70 ai malati di Aids (cui nel 1986 dedica un libro) degli ’80 e ’90; dagli «Obelischi» di preservativi ai «Black Heroes»; dal film «Daddy», in cui affronta la violenza subita a 12 anni dal padre, fino agli «oggetti d’incontro»: manufatti di culture del mondo intero di cui il Mudec è così ricco. Ma non basta: quando, alla fine, si trasferì a San Diego, Niki rese omaggio alla dea dei nativi, Califia, divinità eponima della California, e creò anche «Teschi» luccicanti, espressioni del suo sincretismo.
Il 12 ottobre esordisce poi la mostra «Dubuffet e l’Art Brut. L’arte degli outsider» (fino al 6 febbraio; prodotta da 24 Ore Cultura con Fondazione Deloitte), ideata per il Mudec da Sarah Lombardi e Anic Zanzi con Baptiste Brun per la sezione dedicata a Jean Dubuffet, l’artista francese (1901-85) che la teorizzò e che donò a Losanna la Collection de l’Art Brut.
Che cosa sia l’Art Brut è presto detto: è «l’arte dell’istinto, dell’anima nuda, dell’espressione incontaminata, che non si preoccupa delle regole, delle tecniche accademiche o delle convenzioni»; è l’arte degli emarginati, dei malati mentali, degli internati, che parla un linguaggio estraneo a ogni norma codificata. Qui sfilano oltre 70 opere, alcune (di Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli, Émile Ratier e dell’italiano Carlo Zinelli) della collezione originaria di Dubuffet, poi sempre arricchita. Il percorso si apre con 18 importanti opere dell’artista francese, che attingeva ad antropologia, etnografia, folklore, psichiatria, in cerca dell’alterità artistica, perché, diceva, «ogni uomo comune è un artista in nuce». Poi, ecco l’Art Brut, con i suoi mondi imperscrutabili e destabilizzanti, cui seguono le due sezioni dedicate alle Credenze (l’occultismo di Marie Bouttier, il dialogo con gli spiriti di Madge Gill e altro ancora) e al Corpo, con le anatomie inquietanti di Guo Fengyi, Giovanni Bosco, Giovanni Galli, Sylvain Fusco e altri, in un corpus di lavori dotati di un’incredibile potenza emotiva ed estetica.

«Luogo affollato» (1982) di Jean Dubuffet, Musée cantonal des Beaux-Arts, Losanna. © Musée Cantonal des Beaux-Arts, Losanna Jean Dubuffet. © Jean Dubuffet by Siae 2024