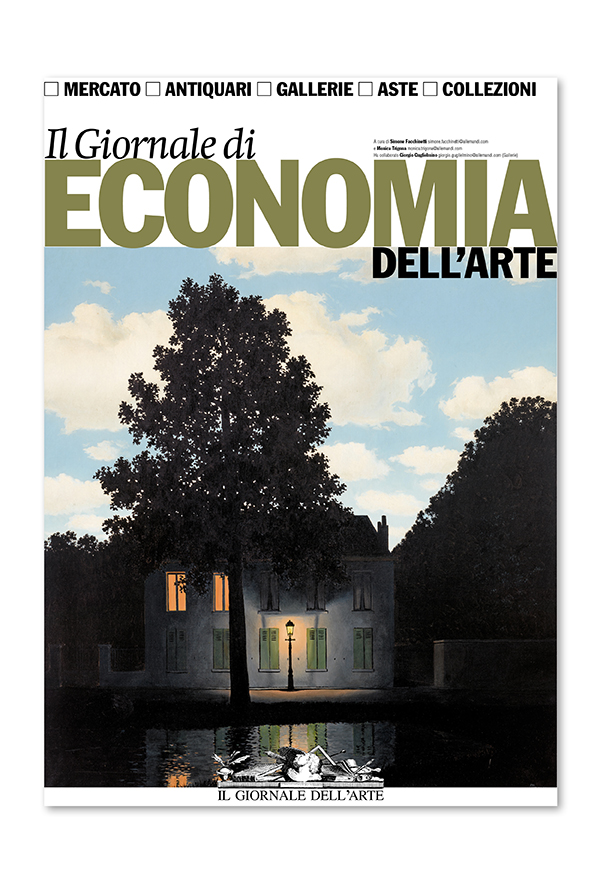Aperta sabato 7 settembre, rimarrà allestita fino all’1 dicembre la 15ma edizione della Biennale di Gwangju, in Corea del Sud. La rassegna del trentennale riunisce 72 artisti provenienti da 30 Paesi (nessun italiano), riuniti sotto il titolo «Pansori: A Soundscape of the 21st Century» (Pansori: un paesaggio sonoro del XXI secolo), un tentativo di mappare la complessità del mondo contemporaneo. Ne parliamo con il direttore artistico della Biennale, il critico e curatore francese Nicolas Bourriaud (1965).
Il titolo della mostra di quest’anno «Pansori, a Soundscape of the 21st Century» si riferisce a una forma musicale tradizionale coreana. Può spiegarcelo?
Il «pansori» è apparso per la prima volta nei pressi di Gwangju, in Corea, alla fine del Seicento, per accompagnare i rituali sciamanici. In coreano «pan» significa mercato, piazza pubblica e «sori» rumore o voce. Pansori potrebbe quindi essere tradotto come «suono pubblico» o, ancora, «voce dei subalterni». Facendo delle ricerche, mi sono imbattuto in un film di Im Kwon-taek, «Seopyeonje» (1993), in cui racconta la storia di un vecchio maestro di pansori che cerca di trasmettere la sua arte ai figli. Ho capito che il suo vero soggetto era lo spazio, i paesaggi desertici della Corea del dopoguerra. Il pansori è diventato un'immagine guida, che esprime i due aspetti della mostra: il suono e il territorio. Mi piace ancorare un tema generale a riferimenti locali. Cercavo un’angolazione vernacolare che mi permettesse di affrontare il mio tema, la questione del rapporto tra gli artisti di oggi e lo spazio. Nel 2014, a Taipei, ho dato vita a un ciclo di mostre sull'Antropocene con «The Great Acceleration»; l'ultimo episodio è stato «Planet B» a Venezia nel 2022, sulla nozione di «sublime». Negli ultimi trent’anni il mio lavoro curatoriale ha spesso ruotato intorno alla musica (a 20 anni ero percussionista in una band), l’elemento del suono. E anche se gli occidentali non lo conoscono, il pansori può parlare a tutti: è una sorta di archetipo, un’opera minima.
Qual è la dimensione operistica della mostra?
Si tratta di sovrapporre i territori del visivo e del sonoro. La mostra è concepita come uno spazio di dialogo tra suono e immagine. È strutturata in tre parti, tre motivi sonori che corrispondono a tre tipi di spazio: l'effetto Larsen, che si verifica quando due trasmettitori sono troppo vicini l’uno all’altro, esprime la saturazione e la mancanza di spazio; la polifonia, l’intreccio di più fonti e, in questo caso, il modo in cui gli artisti danno voce a piante, minerali, macchine e a tutto ciò che non è umano; infine, il suono primordiale del big bang, conosciuto nella tradizione indù come «Om», è un punto di riferimento per la ricerca di un altrove da parte degli artisti contemporanei, sia che si tratti dell'infinitamente grande, cioè della dimensione cosmica, sia di quello che io chiamo lo «sguardo molecolare». Lungo il percorso, si passa da un primo piano molto urbano, saturo e claustrofobico, a uno spazio molto aperto, come un deserto punteggiato di oasi. Più concretamente, si entra nella mostra attraverso un lungo tunnel in cui si è immersi in un pezzo sonoro di Emeka Ogboh, basato su una registrazione effettuata nelle strade di Lagos, in Nigeria, e si esce attraverso un piano dedicato al minuscolo, al microscopico. In tutta la mostra, cerco di fare in modo che i suoni si riversino l’uno nell’altro, contrariamente alla logica del «black box».
Lei propone una riflessione sul nostro rapporto con lo spazio: a quali spazi fisici e simbolici si riferisce?
Lo spazio è un tema apparentemente piatto e banale. Ma quello che mi interessa qui è che è un argomento comune per un fisico quantistico o per un tassista. E la domanda fondamentale per me è: in che modo il cambiamento climatico influisce sul nostro rapporto con lo spazio? Dall’innalzamento degli oceani alla crisi degli alloggi, dalle migrazioni climatiche alla cementificazione del pianeta, è la questione dello spazio, quello delle specie viventi e dei loro ecosistemi, a concentrare tutte le sfide dell’Antropocene. E anche le sue questioni politiche. Nel video-saggio che ho girato per la Biennale ho chiesto a un’attrice coreana di leggere un passo del saggio di Virginia Woolf Una stanza tutta per sé (1929). In esso riassume le lotte femministe attraverso l’accesso allo spazio sociale. La filosofa Vinciane Despret, che estende la «teoria del ritornello» di Gilles Deleuze e Félix Guattari, mostra come gli uccelli delimitino il loro territorio cantando. Possiamo collegare questa idea all'mmagine dei migranti che portano con sé il loro territorio sonoro, che «ripiantano» la loro tradizione musicale altrove. Nella mostra ci sono molti riferimenti alla migrazione: nei dipinti di Alex Cerveny, nelle installazioni di Mira Mann, Gaëlle Choisne e Na Mira... Ma anche al rapporto con il suolo geologico, come nei progetti di Sung Tìeu, Lucy Raven, Yuyan Wang e Andrius Arutiunian, che affrontano il tema dell’estrattivismo. Infine, non dimentico che l’arte è anche uno spazio specifico...
Ci sono artisti con i quali ha collaborato più volte, altri meno. Come ha stilato la sua lista?
Il grande Harald Szeemann, che frequentavo al Café Beaubourg di Parigi alla fine degli anni Novanta, mi ha dato un consiglio che ho sempre seguito. Mi disse che, per le grandi mostre collettive, divideva la lista in tre: un terzo di artisti affermati o storici, un terzo di artisti emergenti... e un terzo di amici. Con questo termine intendeva artisti che erano «compagni di viaggio», con i quali aveva instaurato rapporti duraturi. A Gwangju, quest’ultimo terzo è rappresentato da Philippe Parreno, Liam Gillick e Angela Bulloch, che ritrovo dopo un lungo periodo e che raramente sono presenti in questo tipo di mostre. Ci sono anche Ambera Wellmann e Max Hooper Schneider, le cui mostre personali ho già programmato a Montpellier. Ma una biennale è sempre un'occasione per lavorare con artisti più giovani, per conoscere il loro lavoro. Penso a Jura Shust, Amol K Patil, Na Mira, Kandis Williams, Noel W. Anderson, Brianna Leatherbury... Senza dimenticare due pittori straordinari, Beaux Mendes, l’erede transgender di una lunga stirpe di rabbini, e Dominique Knowles, che qui espone un dipinto lungo 30 metri...
Può citare alcune delle opere prodotte per la Biennale?
Marguerite Humeau presenta un’opera davvero ambiziosa, che combina le pulsazioni del pansori con le stromatoliti, forme di vita primitive; Hyewon Kwon, che ha lavorato nelle grotte sottomarine dell'isola di Jeju, in Corea del Sud, mostra come il suono venga utilizzato per misurare scientificamente uno spazio immerso nell’oscurità. Max Hooper Schneider ha creato una gigantesca installazione di ecosistemi e Oswaldo Maciá ha viaggiato per il mondo per registrare il vento in vari deserti.
La mostra si estende alla città: in quale forma?
Date le dimensioni di Gwangju (la città si estende su una superficie di oltre 500 kmq e ha circa1 milione e mezzo di abitanti, Ndr), non volevo disperdere troppo la mostra. Ho organizzato una seconda parte a Yangnim. In questo quartiere storico, dove si stabilirono i missionari cristiani, un’opera di Saâdane Afif «attraversa» la città da una stazione di polizia in disuso; c’è anche una magnifica installazione sonora di Marina Rosenfeld. Ma la mostra principale irriga anche Gwangju, così come le sculture di Franck Scurti realizzate con i rifiuti delle discariche della città. Infine, per tutta la durata della Biennale sarà aperto un ristorante, il Madang food lab. Gilles Stassart, che gestisce una sorta di pizzeria sperimentale sull'sola di Sado, nel nord-ovest del Giappone, cucinerà un menu in cui i clienti dovranno scegliere gli ingredienti uno per uno.
Come percepisce l’attuale scena artistica coreana?
La Corea è un Paese piuttosto «radicante», se così si può dire... [I radicanti sono piante che, avanzando, fanno crescere le radici. Si veda il saggio di Bourriaud Il radicante. Per un’estetica della globalizzazione, uscito in Francia nel 2009 e tradotto in Italia da postmediabooks. Radicants è anche il nome della «cooperativa curatoriale» internazionale creata da Bourriaud e lanciata nel gennaio 2022, Ndr]. Due terzi della popolazione sono cristiani, un terzo buddisti. La loro identità è quella di un Paese che è stato a lungo invaso dai suoi vicini, che sa includerli e che si vede nel presente. Questo spiega la popolarità del suo K-pop e del suo cinema. Alla Biennale partecipano dodici artisti coreani, tra cui Haneyl Choi, che ha una fama davvero internazionale, e artisti di Gwangju, come Jayi Kim, che distilla erbe raccolte nel raggio di 100 metri dallo spazio espositivo...

Nicolas Bourriaud, direttore artistico della 15ma Biennale di Gwangju. Foto Sergio Rosales Medina