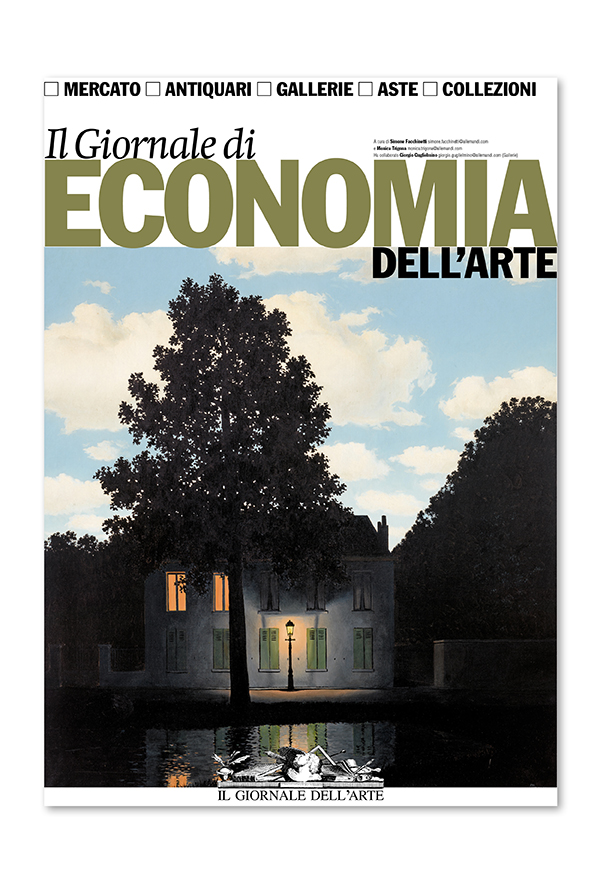Simone Verde
Leggi i suoi articoli«Non so perché, ma non mi sono imbattuto in Dante se non tardi [...] Se ne ho avuta una copia, non credo di averlo letto. Ma siccome è sempre più di moda, temo che una di queste umide mattine mi toccherà leggerlo».
A parlare è uno dei personaggi di Nightmare Abbey, novella a chiave scritta nel 1818 da Thomas Love Peacock, funzionario della Compagnia delle Indie Orientali dalle grandi pretese letterarie: l’Honourable Mr. Listless, ozioso dandy e quintessenza del lettore borghese, allude qui a una vera e propria moda dantesca scoppiata dopo la traduzione in versi liberi della Divina Commedia nel 1814, a opera di Henry Cary e recensita favorevolmente, tra gli altri, da Coleridge e persino da Ugo Foscolo. Apparsa in piena epoca georgiana, questa versione generò una vera e propria «dantemania» che dalla letteratura passò presto alle arti, finendo per identificarsi con la stagione romantica e con alcuni dei suoi più significativi orientamenti politico-estetici. Da britannico, il fenomeno si associò al rigetto complessivo dell’Illuminismo francese che, nella novella di Love Peacock e a qualche anno dal Congresso di Vienna, andava alla ricerca di una mitologia alternativa a quella classica, con una certa nausea verso l’eroismo classicista della Rivoluzione Francese, tanto più vista la violentissima avventura napoleonica.
Va considerato che, prima di determinarsi in Dante, la storia rinascimentale di Firenze era di moda già da un pezzo nel dibattito pubblico inglese, dacché la città era parsa da sempre esemplare nel confronto tra i vizi e le civiche virtù, individualismo e collettività. Lo dimostrano i numerosi riferimenti contenuti nell’opera dello storico britannico per eccellenza della seconda metà del Settecento, Sir Edward Gibbon. Il mito si era andato rafforzando nel momento in cui il fiorire artistico, manifatturiero e finanziario della Firenze del XV secolo era stato scelto come origine leggendaria dello sviluppo economico e industriale dell’Europa dei Lumi. Quando, però, nell’ultimo scorcio di secolo l’apparizione tumultuosa di una borghesia eversiva - per interessi e immaginario - al sistema dell’Ancien Régime incrinò ormai irreversibilmente le illusioni della ragione e produsse una delle crisi sociali più acute e incontrollabili di tutti i tempi, si dovette cercare in altre inedite pieghe della storia fiorentina. Di fronte agli stravolgimenti della prima industrializzazione, alla privatizzazione delle terre e all’inurbamento di una massa inimmaginabile di disperati, dalla Firenze del Rinascimento si cominciò a guardare, quale paradigma, a quella del secolo di Dante.
Più che la Divina Commedia, al massimo vista come un prototipo ancestrale del Paradiso perduto di Milton, fino a quel momento i britannici eruditi avevano letto, apprezzato o al massimo saputo dell’esistenza del De Monarchia. Per ragioni ideologiche, ovvero l’attacco frontale alla pretesa legittimità teocratica del papato contenuta in quello scritto. Si dovette aspettare il 1719 e un uomo come Jonathan Richardson per assistere a un cambiamento di prospettiva. Fu allora che questo artista, collezionista ed erudito, autore del Discours on the Science of a Connaisseur, testo cruciale nella storia del gusto in cui veniva definita per la prima volta la figura del «conoscitore d’arte», si riferì a Dante come a un grande poeta, utilizzandone la statura letteraria per un paragone tra le arti. Riguardo la tragica storia del Conte Ugolino così come raccontata da Giovanni Villani nelle Cronache Fiorentine e nella Commedia di Dante, Richardson concluse che se la poesia del secondo aveva potuto molto di più che la storiografia del primo, «la stessa vicenda, dipinta con tutti i vantaggi [...] del colore da un genio equivalente e superiore a quello di Michelangelo, sarebbe stata ancora più efficace». Cinquant’anni dopo, con la crescente diffusione della Commedia in lingua inglese, il paragone tornò d’attualità e nel 1773 Joshua Reynolds, che nelle sue collezioni possedeva un disegno di Virgilio, Dante e Ugolino attribuito a Luca Signorelli, si cimentò in una tela dallo stesso soggetto - Il Conte Ugolino e i suoi figli incarcerati - oggi custodita al British Museum, il cui colorismo sembra rispondere alla sfida lanciata da Richardson, ovvero dimostrarsi artista pari o superiore a Michelangelo, magnificando il potere narrativo della pittura sulle altre arti.
Nel 1769 e sulla stessa scia, lo scrittore svizzero Jakob Bodmer, questa volta per dimostrare la superiorità della parola sulle immagini, aveva dato alle stampe un dramma storico, Der Hungerthurm in Pisa, tutto incentrato sulla figura di Ugolino. Tra i suoi allievi, Bodmer annoverava un talentuoso Henry Fuseli che, una volta trasferitosi a Londra ed entrato in contatto con Reynolds - proprio lui -, imboccò sotto la sua influenza la strada della pittura. Durante un lungo soggiorno a Roma, che si protrasse dal 1770 al 1778, studiò quindi Michelangelo ed eseguì illustrazioni della Divina Commedia, tutte ispirate a quelle miniate da Sandro Botticelli tra il 1480 e il 1495 su commissione di Pierfrancesco de’ Medici, che aveva potuto ammirare in città. A questo punto i temi fondamentali dell’iconografia dantesca erano ormai noti al mondo britannico e a quello germanico, tanto più quando, nel 1791, apparve il saggio Über des Dante Alighieri Göttliche Komödie a opera di August Wilhelm von Schlegel, il quale tradusse e commentò ampie parti della Commedia, dando il via agli studi danteschi anche nel cuore continentale dell’Europa tedesca.
Fu nella Gran Bretagna degli anni settanta che si verificò tuttavia la serie rapidissima di passaggi con cui la riscoperta divenne una vera e propria «dantemania». Il primo avvenne nel 1773 quando il bibliofilo Roger Wibraham acquistò copia della celebre edizione della Divina Commedia di Cristoforo Landino contenente riproduzioni a incisione dell’opera di Botticelli che fece circolare negli ambienti eruditi. Alcuni anni dopo, tra 1785 e 1786, ecco che due tavole vennero riprodotte nel Bibliographical Dictionary of Engravers di Joseph Strutt, entrando così ufficialmente nell’immaginario degli artisti e degli amatori. Un secondo passaggio venne sancito qualche anno più tardi quando John Flaxman realizzò la sua impegnativa serie di illustrazioni della Divina Commedia commissionatagli da un aristocratico del solito giro di patiti del Grand Tour, Thomas Hope. A quel punto, in una delle accelerazioni tipiche dei fenomeni di moda, nel 1803 ben 88 pagine disegnate «dalla mano di Botticelli o di un altro disegnatore eccellente dello stesso periodo», le stesse studiate da Fuseli a Roma, finirono nelle mani di un celebre libraio-antiquario italo-parigino, Giuseppe Molini, e vennero acquistate da un nobile collezionista scozzese, Alexander Hamilton, per arricchire le raccolte di famiglia dove rimasero fino al 1882. Giocoforza, nel 1807 Hope sentì tutto l’interesse di pubblicare l’album commissionato a Flaxman, che diede alle stampe con il titolo Compositions from the Divine Poem of Dante: la dantemania era oramai un fenomeno di mercato, al punto che il Lucifero della Commedia illustrata da William Blake nel 1824 prese le fattezze di una deità indù - Durga, consorte di Shiva - in un sincretismo in voga sotto gli auspici della Compagnia delle Indie.
Potrebbe sembrare strano che il movimento sia partito dal mondo anglosassone e non da quello latino, magari dall’Italia, ad esempio da un artista come Francesco Scaramuzza. A ben pensarci, però, non lo è. Il Romanticismo ha infatti radici innanzitutto tedesche, tant’è che l’atto di nascita di questa corrente speculativa viene considerato un piccolo pamphlet tanto polemico quanto folgorante, ovvero la Metacritica alla Critica della ragione pura (1798) di Johann Gottfried Herder in cui viene smascherata la pretesa universalità della ragione illuminista, in particolare nella versione assunta da Immanuel Kant. Herder fa notare come la conoscenza, incardinandosi nel linguaggio più che in un assoluto, può aspirare semmai a una rivelazione culturale, un po’ come il percorso catartico dantesco non può fare a meno della carnalità e della mortalità, né delle radici spaziali - storiche - in cui si snoda ogni percorso di rivelazione. Nell’impossibilità di accedere direttamente alla verità, la ragione è dunque costretta a compiacersi delle sue determinate apparizioni nel vissuto di ciascuno, a farsi bastare i suoi rispecchiamenti, le sue immagini proprio come quelle che nel viaggio spirituale il poeta riporta quale unica espressione comunicabile del suo avvicinamento a Dio. Tutte esperienze individuali, dunque, la cui sommatoria nelle singole comunità altro non è se non storia, sedimentata in diverse lingue, ovvero in diverse culture nazionali.
Questo intreccio teorico dimostra come non fu soltanto il Dante dell’Inferno e delle sue immagini truculente ad attrarre l’Europa romantica ma anche la sostanza teologica delle altre cantiche, tanto più se si considera l’origine spirituale e religiosa del movimento. Un incontro in qualche modo predestinato e dalle mille implicazioni, anche politiche. Herder, discutendo di filosofia da patriota e pastore luterano, infatti, polemizzava anche contro la base sociale e politica dell’Illuminismo, ovvero contro la rete cosmopolita di interessi che si celava dietro l’ideologia universalista. Il frazionamento politico degli stati tedeschi avversava le pretese espansionistiche francesi e il loro sistema economico borghese, non a torto, come sarebbe stato dimostrato di lì a poco dalla sanguinaria epopea napoleonica. Ecco allora che attraverso la riscoperta di Dante, e per forza di cose a partire dal mondo anglosassone, si compiva una riscoperta dell’assoluto dello spirito, più che un allargamento dell’universale della ragione, che da una comunità specifica e da una precisa stagione della storia avrebbe potuto essere di insegnamento se inteso e compreso a vantaggio di un’altra, ma per analogia, nel rispetto delle dovute differenze, cioè, e non per emulazione.
Un Dante francese
L’impianto ideato dai britannici e dai tedeschi finì presto per sedurre i settori più conservatori della società francese, dove la riscoperta tardiva di Dante - tardiva solo perché tardi si affermarono gli ambienti e le correnti che si erano già identificati altrove nella Divina Commedia - avvenne nei primi dieci anni del 1800 per poi, da qui e solo a questo punto, estendersi all’Italia. La prima tela esposta al Salone del Louvre con soggetto dantesco fu un saggio accademico di stampo neoclassico sulla Morte di Ugolino di Fortuné Dafau, una derivazione mal riuscita dell’originale di Reynolds. Oltre questa ripresa pedissequa e senza interesse, tutta in emulazione dell’archetipo britannico, la prima vera e propria attestazione d’interesse è del 1807 e ricorre nella Corinne di Madame de Staël in cui la protagonista e alter ego dell’autrice, definisce il poeta fiorentino «l’Omero dei tempi moderni», «il sacro poeta dei nostri misteri religiosi». Definizioni rivelative di un interesse ispirato da Schlegel e improntato a un patriottismo tedesco dai già sottolineati valori liberali, e davvero precoce, se si pensa che solo quattro anni prima, nel 1803, le celebri illustrazioni botticelliane, partite probabilmente da Roma nel tristissimo clima delle razzie napoleoniche si erano trovate in vendita da Molini senza suscitare a Parigi lo stesso interesse che oltre Manica, tant’è che avevano preso la strada della Scozia.
Il posizionamento sociale e politico della nobildonna nei piccoli circuiti del potere dell’Europa del tempo non corrispose a una scelta, quanto a una predestinazione, figlia com’era dell’ex ministro delle Finanze di Luigi XVI, Jacques Necker. Vicina a Benjamin Constant, il teorico della democrazia quale risposta moderata al repubblicanesimo rivoluzionario, Madame de Staël annoverava nel circolo culturale di cui fu animatrice l’economista ed erudito svizzero Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi cui si deve, nel 1813, sotto la sua influenza e quella - nessuna sorpresa - di Jonathan Richardson, la seconda rigenerazione francofona del mito di Dante. Una rigenerazione molto diversa rispetto a quella dell’area anglosassone in cui, non potendo per ovvie ragioni la figura del poeta fiorentino assumere valenze antifrancesi - e quindi anti-illuministe -, venne a simboleggiare il rinnovamento dell’ethos liberale dei lumi nella memoria immanente dei popoli, ovvero una ripresa romantica della mitologia politica di Voltaire. Nel De la litérature du midi de l’Europe, pubblicato nel 1813, Sismondi si lanciò in una esaltazione della poetica dantesca, in quanto disposta a riconciliare naturalismo e immaginazione creativa; capace di elevare la realtà all’arte secondo uno schema simile a quello proposto da Herder, per cui la conoscenza, partendo da una realtà determinata si fa lingua e, in quanto espressione culturale, e solo in quanto tale, è declinazione dell’assoluto.
Mancava solo un gradino per il passaggio a una pratica finalmente innovativa nelle arti figurative e fu cosa di qualche anno appena, grazie a uno scrittore: Stendhal. Inutile dire che da appassionato di cultura italiana, egli partiva da una condizione privilegiata. Ma ancora di più se si considera che sua madre, Henriette Gagnon, morta di parto quando era ancora piccolo, conosceva la Divina Commedia in italiano, e che questo aveva fatto dell’universo dantesco un riferimento che lo scrittore legò per tutta la vita alla figura materna. Lo racconta lui stesso nella Vie d’Henry Brulard, l’incompiuta autobiografiadel 1835 dove fa sapere che il «rispetto per Dante è cosa antica e data degli esemplari che ho trovato negli scaffali della biblioteca di mio padre, occupati dai libri della mia povera madre». Tale rarissimo, precoce interesse sarebbe stato poi rafforzato negli anni della formazione dall’aver seguito i corsi di Joseph-Gaspard Dubois-Fontanelle all’Università di Grenoble, che includevano riferimenti alla Divina Commedia. E si sarebbero coniugati con la dantemania oramai imperante in Germania e in Gran Bretagna, al punto da dipanare le considerazioni sull’opera dantesca nel solco della tradizione iniziata nel 1719 dal solito pioniere, Sir Jonathan Richardson.
L’attenzione di Stendhal si appuntò quindi sull’episodio del Conte Ugolino e riprese un parallelo già proposto da Madame de Staël, ovvero che la poesia di Dante sarebbe «la più terribile che esiste, neanche il divino Omero ha qualcosa di simile». Eccolo poi citare il dipinto di Joshua Reynolds e farne un riferimento imprescindibile, una eccezione mirabile al confronto con «tutte le stampe che ho visto su Dante, che sono di un ridicolo assai divertente». Nella tela del pittore inglese ricorre, a suo dire, una «forza indispensabile, niente di più raro al giorno d’oggi», una forza che, come spiegherà altrove, avrebbe a che vedere solo con quella di Michelangelo. Nella Histoire de la peinture en Italie apparsa nel 1817, la forza estetica travolgente del Giudizio Universale della Sistina sarebbe addirittura dovuta all’influenza del poeta fiorentino. E non solo. Il Bacco di Michelangelo racchiuderebbe accenti danteschi: la statua non ha «quel carattere di abbandono e di voluttà che respira nel Bacco antico» ma trattasi invece - o meglio, addirittura - «di un idillio scritto nello stile di un Ugolino». A riprova che l’apprezzamento di Stendhal fosse schiettamente romantico, la grandezza di ogni artista sarebbe nell’incarnare lo spirito e le tensioni del suo tempo. «Vuoi comprendere Michelangelo? - domanda retoricamente - Immedesimati in un cittadino di Firenze nel 1499!». A ritroso - da Madame de Staël, a Reynolds e fino a Richardson -, il cerchio che aveva originato l’invenzione romantica della iconografia dantesca era stato richiuso.
A segnare finalmente il passo, dopo una serie di prime apparizioni iconografiche prive di originalità ma ispirate alla dantemania britannica e tedesca, fu la celeberrima Barque de Dante dipinta da Eugène Delacroix nel 1822, debitrice diretta di Stendhal e, più precisamente, della succitata Histoire de la peinture en Italie del 1817. Atto inaugurale di questa specifica iconografia, essa riverbera nelle forme della composizione l’etica dei circoli del romanticismo liberale e conservatore. L’opera apparve tre anni dopo la celebre Zattera della Medusa di Théodore Géricault che per soggetto, stile e violenza era diventata un’icona degli ambienti rivoluzionari: la sua storia è nota e si riferisce a un fatto di cronaca, una ciurma di poveri marinai condannati alla deriva da autorità incompetenti, costretti a cannibalizzarsi per sopravvivere, diventati metafora dello sbando subito dal popolo dopo la Restaurazione. L’assenza di citazioni mitologiche, o piuttosto la creazione esplicita di una mitologia tratta dalla cronaca, il riferimento alla magniloquente pittura di Michelangelo e di Rubens ma per magnificare un soggetto umile, ne avevano fatto un vero e proprio manifesto estetico e politico con cui Delacroix, di otto anni più giovane di Géricault e alla ricerca di consacrazione, non avrebbe potuto non fare i conti.
Dal 1819 al 1822, però, il contesto politico era cambiato, e di molto. Il 14 febbraio 1820 era stato assassinato per mano di un rivoluzionario l’ultraconservatore duca di Berry, ultimo discendente della famiglia reale di Borbone. In Europa e in America Latina, i moti rivoluzionari erano stati soffocati nel sangue e avevano ceduto il passo a una stretta reazionaria che non avrebbe potuto che coinvolgere anche la storia dell’arte. Se la Barque di Delacroix, sospesa in mezzo ai flutti e minacciata da dannati non troppo dissimili a disperati cannibali ricordava globalmente la Zattera, parzialmente diverso doveva essere il messaggio politico. Analizzando gli studi preparatori dell’opera, in gran parte debitrice della lezione di Flaxman, emerge tutta la preoccupazione di Delacroix di rendere il più centrale e assiale possibile la figura di Virgilio e ancillare quella di Dante. Il poeta fiorentino rappresentava certo il dirompente realismo dell’ethos popolare, ma Virgilio lo avrebbe moderato, instradato nel solco di una tradizione classica ancora viva nella monarchia. Preso nel viaggio tanto infernale quanto rigeneratore degli istinti, il popolo avrebbe potuto trovare rifugio nel dispotismo illuminato della Restaurazione.
Inutile elencare il resto dei riferimenti iconografico-politici di quest’opera paradigmatica di un momentaneo riflusso politico e delle preoccupazioni di un pittore impegnato a garantirsi committenze ufficiali. Basti dire che venne accolta con entusiasmo da un giovane conservatore, uno dei maggiori sostenitori della monarchia liberale, il futuro presidente della Repubblica Adolphe Tiers all’epoca avvocato di provincia, giornalista e commentatore di fatti culturali, il quale scrisse: «L’autore ha oltre all’immaginazione poetica, che è comune al pittore come allo scrittore, quell’immaginazione dell’arte che possiamo dire del disegno. Scaraventa figure, le raggruppa e le piega a volontà con l’ardire di Michelangelo e la fecondità di Rubens. Non so quali grandi artisti evoca per me questo quadro [...] Non credo di sbagliarmi, ma M. Delacroix ha toccato il genio». Potenza «ardente», dunque, ma «naturale»; colore, ma anche disegno, insomma una sintesi degli opposti che era aspirazione della Francia postrivoluzionaria, prudente espressione di dissenso da parte dell’autore e prefiguratrice del gusto più che aristocratico, borghese, della casata d’Orléans che proprio Thiers contribuirà nel 1830 a far salire al potere.
Questa dimensione conservatrice dell’iconografia dantesca trovò espressione ancora più esplicita qualche anno più tardi in un’opera di committenza ufficiale. Nel riallestimento di sette sale delle collezioni archeologiche del Louvre, per quello che avrebbe dovuto chiamarsi Museo Carlo X e che avrebbe dovuto perpetuare la tradizione delle committenze borboniche del palazzo, nel 1827 venne commissionata a Jean-Auguste-Dominique Ingres una monumentale Apotheose d’Homer da issarsi sul soffitto della sala omonima. Nell’enorme tela, più tardi sostituita da una copia ed esposta in piedi su un muro dell’Ala Denon, Omero ha le sembianze di una divinità e raccoglie l’omaggio di tutti gli uomini di genio della Grecia, di Roma e dei tempi moderni tra i quali, immediatamente a sinistra, si intravvede Dante nell’atto di consegnargli la Commedia. Il sommo poeta italiano, da icona di una mitologia cristiana, popolare e anticlassica si vedeva qui trasformato nel perpetuatore della tradizione antica. Persino l’idea espressa da Madame de Staël di un nuovo Omero, poiché entrambi cantori trobadour, era stata trasformata nel suo contrario: la dantemania aveva ormai conquistato la Francia.
Stando alle statistiche, tra il 1800 e il 1939, Dante venne citato oltralpe almeno 294 volte a opera di artisti più o meno noti, consacrati, emergenti o avanguardisti. Una cifra alquanto ragguardevole dietro cui si cela un po’ tutta la paletta delle sue infinite mitologie, al servizio di qualsiasi tesi e del suo contrario. Nato come simbolo politico, se il mito di Ugolino era servito per illustrare il cannibalismo di una élite capace di nutrirsi dei suoi figli, durante la Monarchia di luglio servì per rappresentare l’opposto, vale a dire l’ingiusta sorte riservata agli aristocratici sotto la Rivoluzione Francese, tant’è che nell’Arrestation du comte Ugolino (1837) di Henri Delaborde, il nobiluomo viene rappresentato impassibile e con dignità aristocratica, in ripresa dell’iconografia del Cristo al cospetto di Ponzio Pilato. Una più banale pacificazione arrivò con il bonapartismo di Napoleone III, dove il regime borghese prese le sembianze di un sistema dispotico e monarchico ma di sangue rivoluzionario. E allora l’Ugolino in bronzo di Jean-Baptiste Carpeaux esposto al Salone del 1863, molto debitore del Laocoonte, del Mosè di Michelangelo e della Zattera di Géricault, si propose come una meditazione etica e astrattamente teoretica sul senso della storia. Una meditazione che ritroviamo, in altro regime politico, al più alto potenziale espressivo nella Porta dell’Inferno di Rodin, del 1885.
Miracoloso Alighieri, la cui feconda vena mitologica venne strumentalizzata in ogni poetica, tanto che i festeggiamenti per i 600 anni dalla nascita consacrarono universalmente il suo multiforme mito. Persino quello del nazionalismo, il quale si basò su una libera lettura di Boccaccio, che nella Laude di Dante aveva messo l’accento sul suo spirito incompreso, perseguitato ed errante, stereotipo dell’intellettuale romantico alla ricerca di una patria, che scopre essere solo ideale e letteraria. Da qui la serie infinita di opere illustranti Dante a Verona, Dante a Ravenna... e persino Dante a Parigi: «Fu ancora questo poeta di meravigliosa capacità e di memoria fermissima e di perspicace intelletto - scrive Boccaccio -, intanto che, essendo egli a Parigi, e quivi sostenendo in una disputazione de quodlibet che nelle scuole della teologia si facea, quattordici quistioni da diversi valenti uomini e di diverse materie, con gli loro argomenti pro e contra fatti dagli opponenti, senza mettere in mezzo raccolse, e ordinatamente, come poste erano state, recitò; quelle poi, seguendo quello medesimo ordine, sottilmente solvendo e rispondendo agli argomenti contrari. La qual cosa quasi miracolo da tutti i circostanti fu reputata». La dantemania francese fu di tale abbondanza da contemplare l’appropriazione nazionale che nel 1882 valse al poeta una statua a tutt’altezza davanti al Collège de France e che, nel 1897, vide intestargli una strada. La stessa citata nel Canto X del Paradiso, quel «vico de li Strami», ovvero «rue du Fouarre», dove secondo l’Alighieri avrebbe abitato Sigeri da Brabante. Non testimoniava, questa precisa citazione topografica, del suo viaggio a Parigi e soprattutto un riconoscimento alla città quale capitale intellettuale d’Europa?
Finalmente l’Italia: il romanticismo di Scaramuzza
Che l’Italia fosse rimasta a lungo spettatrice di questa reinvenzione del suo patrimonio letterario non sorprende ed è ben illustrato - non senza un certo compiacimento - da Stendhal: «Quand’è che la morte dà inizio alla posterità di un grande uomo, per cui un mezzo secolo è alla moda e il mezzo secolo dopo è incompreso? Dante, oggi adorato in Italia, cinquant’anni fa passava per un barbaro noioso e nulla ci assicura che nel duemila non sarà di nuovo dimenticato per un secolo o due». Se ci sembra di poter affermare con una certa precisione, a oltre vent’anni dall’anno duemila, che nulla ci sia più da temere circa la longevità dell’eredità letteraria dantesca, cinquant’anni prima della pubblicazione della Histore de la peinture in Italie corrisponde più o meno al 1770. Stando alla ricostruzione di Stendhal, cioè, l’Italia recuperò orgoglio e memoria del suo più importante poeta medievale, ma solo in seguito alla riscoperta britannica e tedesca. Non prima: terra di importazione di una mitologia elaborata da altri e che solo di riflesso riguardò sé stessa.
Non è un fatto nuovo per quegli anni, e Adolfo Venturi nel 1887 denunciava sulla «Rivista Storica Italiana» una situazione simile nel campo della storia dell’arte: «Mentre si analizza, si rinnova la nostra storia politica, letteraria, scientifica - scriveva - pochi e scarsi cultori, sforniti di mezzi di studio, con metodi diversi, senza unità d’intenti, senza la forza che dall’unità deriva, provano a lumeggiare alcuni tratti oscuri, inesplicati ancora della storia dell’arte [...]. Ormai siamo a questo: che ogni grande artista nostro trova monografie, ogni nazionale monumento illustrazioni, ogni fasto dell’arte italiana la sua storia all’estero». Il riferimento andava alla controversia sulle origini del Rinascimento, in cui l’Italia era diventata terreno di scontro tra Francia e Germania, senza prendere parte al dibattito che la riguardava. Lo stesso termine Rinascimento, in effetti, era stato coniato come categoria critica in Francia ed era stato utilizzato per la prima volta nel 1839 da Jacques Ampère nella Histoire littéraire de la France avant le xiie siècle, ripreso da Jules Michelet nel 1855 con un volume consacrato al xvi secolo - La Renaissance, appunto -, apparso come tomo della Histoire de France. Il fine era di situare il punto d’inizio della civiltà moderna a Parigi, cuore morale dell’Europa, con un’operazione politica e propagandistica.
Nel 1860, lo storico svizzero Jacob Burckhardt si era incaricato della risposta del mondo germanico nella Civiltà del Rinascimento in Italia, servendosi della penisola per contestare la tesi francese. Ne era seguita una frattura profonda e alcune personalità, guidate da Louis Courajod, si resero protagoniste di una radicalizzazione senza precedenti. Courajod, conservateur del dipartimento di scultura, occupava anche la cattedra di storia dell’arte dell’École du Louvre, dove vi sostenne, come da una tribuna, la primogenitura della Borgogna nel risveglio del xv secolo, a suo avviso scaturito dal gotico fiammingo. Poco importa che questa operazione confondesse il realismo magico del Nord con l’idealismo metafisico del Rinascimento italiano, purché la penisola venisse marginalizzata e la Francia esaltata. «I francesi - scrisse Venturi -, mossi da pregiudizi di amor patrio, da parecchi anni lavorano a dimostrare che il Rinascimento italiano tornò alla Francia nocivo e fatale; nessun giovane trovò parole per stimmatizzare il chauvinisme francese, o meglio per contrapporvi un libro serio sul predominio dell’arte italiana al di là delle Alpi. In una grande rivista di Parigi si bestemmiò Raffaello, e non un giornalista lanciò cavallerescamente il guanto di sfida al bestemmiatore [...]. In Germania [...] alacremente si lavora intorno alla nostra storia dell’arte, ma di quel lavoro non viene a noi che scarsa notizia». Inutile ribadire che la stessa situazione si stava verificando con Dante.
E in effetti piuttosto magra, se comparata al resto d’Europa, fu la produzione artistica italiana di ispirazione dantesca, in continuità con il prolungato oblio di cui parlava Stendhal. Se si fa l’eccezione di un volume illustrato stampato a Venezia, pubblicato da Antonio Zatta tra il 1757 e il 1758 con una serie di tavole fuori testo riconducibili agli allievi di Giambattista Tiepolo e di Sebastiano Ricci, dedicato a Elisabetta Petrovna, figlia di Pietro il Grande, e poi riedita in versione minore nel 1784, quasi nulla c’è da dire sulla penisola. La situazione cominciò a cambiare, anche se molto lentamente, solo con il nuovo secolo. A Roma, a quel punto, il passaggio incessante di viaggiatori britannici spinse nel 1802 l’incisore Tommaso Piroli a mettere in commercio un’edizione non autorizzata delle tavole di Flaxman, a uso di questo particolare mercato. Sulla scorta della dantemania internazionale due notabili esempi di penetrazione letteraria furono di sicuro il passaggio dei Sepolcri dedicato a Dante Alighieri da Foscolo nel 1806 e, dodici anni più tardi, la tragedia Francesca di Rimini di Silvio Pellico, entrambi legati a due dei più cosmopoliti uomini di lettere italiani.
Solo allora il soggetto cominciò a circolare timidamente, riflesso locale di una moda lontana, come lo dimostrano i formati, l’investimento estetico degli artisti e l’importanza delle committenze, così poco ufficiali che un numero non trascurabile delle opere in questione risulta oggi disperso. Un Paolo e Francesca, probabilmente legato alla fortuna del soggetto dopo il testo di Pellico e commissionato dal conte Saulo Alari di Milano, si deve al fiorentino Giuseppe Bezzuoli, allievo di Pietro Benvenuti, autore a sua volta per la famiglia della Gherardesca di una Morte del conte Ugolino, debitrice - neanche a dirlo - della tela di Reynolds. Ugualmente fu per l’opera dallo stesso soggetto di Giuseppe Diotti per un dipinto del 1817, un quadro oggi scomparso e ripreso da Pasquale Massacra, ma con impronta goyesca, e oggi ai Musei Civici di Pavia. Una svolta arrivò dopo l’apparizione della Barque de Dante di Delacroix, ma non immediatamente e con tempi di mediazione lunghi un’eternità. Si dovette attendere il 1831 per vedere Il conte Ugolino nella torre, tela finalmente di buon formato (174 x 207 cm) di Giuseppe Diotti, oggi ai Musei Civici di Cremona e il 1850 per il Paolo e Francesca di Giuseppe Frascheri, opera finalmente energica, oggi esposta alla Pinacoteca Civica di Savona.
Malgrado questo, però, la logica della committenza fu chiara e, in una sua interpretazione italica, si svolse in linea con il resto d’Europa. Si trattò spesso di famiglie aristocratiche di importanza locale, legate storicamente alle iconografie dantesche, in ogni caso lusingate che dall’eroismo illuminista, fatto di valori razionali e di storie pagane fuori dall’immaginario dell’Ancien Régime, si tornasse nella grande Europa delle nazioni a un più prosaico mondo cristiano. Fu, in maniera significativa, il caso emblematico della più importante committenza italiana del genere, la più importante almeno fino a quel momento, ovvero quella del principe Massimo Lancellotti e del suo secentesco casino romano, che a partire dal 1817 e fino al 1829 venne affrescato con temi tratti dall’Orlando Furioso, dalla Gerusalemme Liberata e dalla Divina Commedia. Il principe scelse, per decorare questa sua raffinata proprietà, un gruppo di artisti di area germanica, tedeschi e austriaci, molti di loro allievi dell’Accademia di Vienna e capeggiati da Johann Friedrich Overbeck, che avevano preso il nome di «Nazareni» vista la predilezione per le iconografie di carattere sacro. Per quello che ci interessa da vicino, la loro estetica si ispirava interamente alle teorie di Schlegel, fondatore degli studi danteschi in Germania; nessuna sorpresa, perciò, che le tre cantiche figurassero in una delle sale del casino.
Pur avendo rifiutato in un primo momento di prendere parte materiale alla realizzazione, a sostenere le scelte della committenza fu un artista austriaco, Joseph Anton Koch, noto per i suoi interessi michelangioleschi e per essersi distinto in un’abbondante produzione dantesca, tra cui una ricca serie di illustrazioni celebrate dallo stesso Schlegel che, in un ragguaglio sullo stato delle arti figurative a Roma pubblicato nella rivista «Athenaneum» del 1805, le aveva poste al di sopra dei disegni di Flaxman in quanto capaci di meglio interpretare la drammaticità dell’Inferno in un più autentico spirito medioevale. I lavori cominciarono dunque nel 1817 e la sala venne dapprima affidata a Peter von Cornelius, che iniziò a eseguire disegni preparatori per la volta finché, dovendo lasciare Roma per Monaco, venne sostituito su consiglio di Koch da Philipp Veit, figlio putativo di Schlegel che, sotto la guida soffocante del patrigno, eseguì il soffitto rappresentante il Paradiso. A partire dal 1825, Veit si dimise e fu infine lo stesso Koch a completare il ciclo, eseguendo le pareti dedicate al Purgatorio e all’Inferno, mantenendosi in gran parte fedele alle indicazioni dello Schlegel. Franz Horny realizzò le ghirlande di frutta e di fiori.
Il risultato, partito dallo stesso impulso Romantico che in Francia, memore di Richardson, aveva guardato come riferimento a Michelangelo e aveva avuto come punto espressivamente più alto la Barque de Dante di Delacroix, a Roma ebbe però esito molto diverso. La congiunzione tra la religiosità dei Nazareni, il romanticismo tedesco e la committenza aristocratica della capitale dello Stato Pontificio diede come risultato un’opera di incredibile impatto emotivo, di indubbio virtuosismo tecnico e compositivo ma priva di modernità. Sembrò piuttosto una riedizione ottocentesca delle Stanze di Raffaello, di tanta pittura quattrocentesca - dall’Angelico a del Castagno - e del Giudizio Universale della Sistina, forse seguendo la suggestione stendhaliana di una sua ispirazione dantesca. Ben lontano dalla tensione civile francese, a Roma il ritorno alla tradizione non sembrò neanche una restaurazione, ma un mero riflusso, non privo di conseguenze, però, per l’italiana dantemania.
Se il ciclo del Casino Massimo fu del tutto germanico per ideazione e per esecuzione, non altrettanto avvenne con il secondo grande cantiere dantesco di quegli anni, eseguito a Parma dal talentuoso Francesco Scaramuzza. L’artista parmigiano, precocissimo e di raro talento, inscritto alla Regia Accademia di Belle Arti di Parma, era stato allievo di Antonio Pasini e Giovanni Tebaldi. Nel 1826 aveva vinto una residenza premio di perfezionamento a Roma, dove era venuto a contatto con l’ambiente dei Nazareni la cui atmosfera aveva contribuito alla codificazione della sua estetica. Per tre anni, e fino al 1829, il pittore spese la sua formazione copiando Raffaello, studiando i classici dell’arte rinascimentale e perseguendo un purismo eclettico sotto l’impronta del circolo romantico. Ma non solo: alla ricerca di una sintesi artistica della civiltà del Cinquecento, Scaramuzza purificò tutte queste tendenze in Correggio, in cui aveva trovato un modello di riuscito compimento. Al periodo romano si datano, malgrado la giovane età, due opere del tutto mature come la Silvia e Aminta e il San Giovanni Battista nel deserto del Complesso Monumentale della Pilotta, finalmente esposti al pubblico dopo un lungo e immotivato esilio nei depositi del museo, in cui si leggono nitidamente tutti gli apporti ricevuti nel periodo degli studi nonché la sintesi avvenuta tenendo a mente la lezione del maestro rinascimentale parmense.
Fu senza dubbio l’esperienza dei Nazareni che legò Scaramuzza a Dante Alighieri, però, nonché altri stimoli come l’aver visto la tela incompiuta con I filosofi della Divina Commedia di Tommaso Minardi oggi alla Pinacoteca di Faenza. Lo dimostrano realizzazioni e progetti relativamente precoci che risalgono alle fasi creative successive al rientro da Roma: nel 1836, dopo sei anni spesi a guadagnarsi un mercato, dipingendo pale d’altare nelle province parmensi, presentò all’Esposizione nazionale di Milano un’opera che rappresentava il Conte Ugolino. La tela, oggi smarrita, riscosse un certo successo e istigò in lui una tutta personale dantemania per cui si consacrò da quel momento in un’impresa che sarebbe durata per il resto della sua vita, ovvero illustrare l’intera iconografia della Commedia e soprattutto realizzare un ciclo dantesco, un po’ come quello del Casino Massimo. Ci provò una prima volta nel 1841, chiedendo al barone Vincenzo Mistrali, all’epoca ministro ducale delle Finanze, di decorare gli immensi corridoi del palazzo dell’università - l’ex collegio gesuitico di Parma - con storie tratte dalle tre cantiche. Non fu questo tuttavia il tentativo più fortunato e Mistrali, seppure suo sincero estimatore, si limitò a consigliargli di cercare altrove.
A Parma, la proposta di Scaramuzza assumeva il valore politico, in effetti, proprio dell’iconografia dantesca del Romanticismo. Non che i circoli risorgimentali della città fossero percepiti come particolarmente pericolosi, ma in un ducato tutto ricompreso in un ritrovato classicismo il suo Dante dovette risultare una forzatura modaiola e velleitaria. Nel dispotico quanto illuminato ducato, la sua proposta dovette risultare sottilmente strampalata, fuori luogo a fronte delle vuote celebrazioni classiciste ancora in voga presso quella innaturale riesumazione dell’Ancien Régime che fu, anche se per poco, il ducato restaurato di Parma e Piacenza. Tanto più che la città non aveva ragioni per amare Dante, anzi. L’unico suo notabile citato nella Commedia, Maestro Benvenuto, soprannominato Asdente, per via della bocca sdentata, era finito all’Inferno (XX, 18-20), nella quarta bolgia del cerchio ottavo dei maghi e indovini, punito dal dover camminare con la testa rigirata sulle spalle «perché volse veder troppo davante». E ancora, nel De Vulgari Eloquentia I, 15 il poeta aveva condannato per la sua crudezza il dialetto dei Parmigiani, troppo triviale per essere annoverato tra le rare forme di «vulgare aulicum». Su questi presupposti, e in assenza di una schiera agguerrita e motivata di sostenitori borghesi dagli orizzonti cosmopoliti, capaci di imporre il senso di una estetica davvero romantica, cioè, il progetto sarebbe potuto rimanere lettera morta, se non fosse che la duchessa, Maria Luigia d’Asburgo, era donna generosa, grande estimatrice del talento dell’artista e se Angelo Pezzana, il quale accolse con favore l’idea di una Sala Dante nel Palazzo della Pilotta, non fosse stato allora direttore della Biblioteca Palatina, instradandolo a decorare l’ambiente che custodiva i preziosi codici e incunaboli danteschi.
Il progetto venne elaborato a partire dal 1836, come testimoniano i ventidue fogli di disegni con l’illustrazione delle prime scene della Commedia fino alla discesa nel Limbo, ma non ebbe vita facile e poté essere concluso soltanto diciannove anni dopo, nel 1855. Si procedette infatti a pezzi. Il primo dipinto venne commissionato il 5 aprile 1841, l’Incontro di Dante e Virgilio coi poeti destinato alla parete Nord della sala, per un compenso molto ridotto, ovvero sole 1200 lire, perché l’artista avrebbe utilizzato un nuovo metodo di pittura a encausto che aveva adottato finora solo sul muro esterno di una abitazione privata di via Farini, con scarsi risultati dal punto di vista conservativo. L’interesse di Scaramuzza per questa particolare tecnica non era nuovo ma risaliva al 1835, quando aveva cominciato a sperimentare un procedimento simile a quello degli antichi ma basato sull’uso di cera a freddo, dissolta in acquaragia destinata a evaporare una volta stesa la pittura sulla parete. Non stupirebbe scoprire che tale scelta fosse ispirata ai precetti di Schlegel, ovvero alla ricerca di un’estetica retrospettiva capace di evocare l’impastamento del colore sulla pergamena delle miniature: la sala che custodiva i manoscritti danteschi sarebbe diventata essa stessa un grande palinsesto illustrato.
Se il primo encausto venne terminato nel 1842 con la raffigurazione del limbo dantesco, il secondo intervento venne contrattualizzato e intrapreso un anno dopo e riguardò Aristotele seduto tra gli antichi filosofi, chiara voglia di confrontarsi con il Raffaello della Scuola di Atene. Nel 1846, seguendo un calendario a singhiozzo, si passò quindi alla realizzazione della volta, scandita da una struttura architettonica che apriva su quattro illustrazioni del Paradiso dove fortissima è l’influenza del Correggio. A quel punto, un rivolgimento politico di primo piano, ovvero l’ascesa al trono ducale di Carlo III di Borbone, dagli orientamenti decisamente più conservatori e ostile all’arte di Scaramuzza, provocò un ennesimo arresto. Dopo un forzato e faticosissimo esilio professionale, il pittore dovette attendere il 1855 - ovvero la morte del duca - per portare a termine le scene dedicate all’Inferno, che completò nei due anni successivi. Come notò al tempo un poeta e uomo di lettere parmigiano, Alberto Rondani, «la Commedia poteva diventare un’arma terribile dell’ingegno italiano, un libro restauratore del nostro carattere: tanto più ch’era già stata osservata una certa coincidenza che non poteva essere sempre stata casuale del risorgere degli studi danteschi e dello scuotersi delle menti anelanti a maggiore libertà». «Poteva diventare» e così in parte fu.
Nel lungo lasso di tempo implicato dalla realizzazione della sala, Scaramuzza non modificò solamente la tecnica esecutiva dei dipinti, sostituendo all’acquaragia oli e resine come solventi della cera, secondo un metodo messo a punto dal pittore lucchese Michele Ridolfi, che come lui praticava la pittura a encausto a freddo. Appare evidente una evoluzione stilistica che comportò la riduzione della gamma cromatica e delle figure della composizione, con una resa più sommaria e compendiosa di grande efficacia espressiva, come risulta nel riquadro sopra la porta ovest con Dante uscito dalla Selva, nella scena di Dante accolto da Virgilio sulla parete a sud tra le due finestre o nel riquadro seguente con Virgilio e Dante sulla porta dell’Inferno. Questa nuova e più drammatica sensibilità raggiunse il culmine nella figura di Caronte che domina gigantesco la scena, illuminato da violenti bagliori di luce che ne sottolineano le caratteristiche demoniache, ulteriore testimonianza della grande capacità inventiva e della fantasia del pittore, soprattutto dopo il 1855 quando, con la morte di Carlo III un potere debole e in mano a un bambino di appena sette anni, guidato dalla reggenza di Luisa Maria di Borbone Francia, lo lasciò libero di allontanarsi sempre più dagli schemi neoclassici.
Travagliatissimo fu dunque questo ciclo dantesco, tutt’altro rispetto alle altre committenze ufficiali che avevano filato lisce come l’olio. Nel 1833, ad esempio, Scaramuzza aveva ricevuto incarico di dipingere le volte dell’appena terminata sala di lettura della Biblioteca Palatina su progetto di Nicola Bettoli. Qui aveva potuto terminare senza intoppi, dacché la decorazione aveva implicato un chiaro intento celebrativo su cui era stato indispensabile concludere, per completare in fretta i riferimenti a Maria Luigia quale protettrice delle arti e delle scienze del ducato in uno stile neoclassico autenticamente schizofrenico rispetto a quello della vicina Sala Dante. Ecco che tra le decorazioni di un finto cassettonato di mano dell’ornatista Girolamo Gelati e dal suo allievo, Filippo Bocchi, si andarono inserendo nella volta due grandi ottagoni dipinti da Giovanni Gaibazzi con gli stemmi dell’augusta committente sostenuti dai Geni delle Scienze e delle Arti, mentre nel comparto centrale era spettato a Scaramuzza un Prometeo che, protetto da Minerva, ruba una scintilla al sole, chiara allusione al governo illuminato della duchessa, al classicismo di Correggio e dell’Aurora di Guido Reni.
Il soggetto, suggerito da Paolo Toschi, rifletteva un gusto armonioso e rispecchiava in assoluta coincidenza di tempi l’indirizzo decorativo formulato da Quatremère de Quincy, di cui il calcografo e direttore dell’Accademia di Belle Arti parmense era amico e corrispondente. Proprio Quatremère, infatti, nel Dizionario storico di architettura del 1832, aveva suggerito l’elegantissima alternanza degli ornati monocromi con brillanti e vitrei cromatismi a fresco, dagli illusionismi studiati in funzione sia dello spazio da dipingere sia dei contenuti etici e morali espressi dal programma iconografico. Per rispondere a questo indirizzo, Scaramuzza aveva utilizzato una tecnica a tempera di notevole trasparenza e luminosità, in una composizione ampia e dilatata dove le figure femminili sono caratterizzate da forme di morbida e dolce rotondità. I lavori - nessuna sorpresa - erano iniziati nel settembre del 1833 ed erano proceduti molto rapidamente, visto che a gennaio dell’anno successivo era stato effettuato il collaudo.
Più tardi, mentre la Sala Dante procedeva a fatica, la committenza ducale si era appuntata su di un altro cantiere ufficiale, questa volta legato alla figura di poeta per antonomasia opposto all’Alighieri, ovvero Francesco Petrarca, che a differenza sua aveva solo speso parole lusinghiere per il parmense. Nel 1838, era stato quindi eretto in sua memoria un monumento nel luogo in cui tra il 1341 e il 1343 aveva soggiornato ospite di Azzo da Correggio, di ritorno dalla cerimonia che sul Campidoglio lo aveva laureato «poeta». Grazie all’impegno di Pezzana, era stato effettuato l’acquisto del sito sulla riva destra del fiume Enza ed era stato costruito per munificenza di Maria Luigia e su progetto di Nicolò Bettoli un tempietto. Ispiratore del progetto era stato il già visto Vincenzo Mistrali che attraverso la figura del poeta avrebbe potuto coniugare orgoglio italico (Petrarca non aveva forse operato una vita per riportare il papa a Roma?), festeggiamento campanilista (il territorio in questione non era entrato nel 1816 nei possedimenti del ducato?) e rispetto delle società liberali seguite alla restaurazione dell’Ancien Régime (non era forse stato un poeta-cortigiano?). Un vero e proprio soggetto patrio, questo dell’episodio petrarchesco, tant’è che figurava già nella succitata volta del salone di lettura della Palatina in un riquadro affrescato a guida di rilievo in bronzo da Stanislao Campana. La decorazione del piccolo sacrario, affidata a Scaramuzza su un’idea di Paolo Toschi - perché i fondi del comitato promotore scarseggiavano e il pittore era uno di quelli che Maria Luigia era solita finanziare di tasca propria -, procedette speditissima e ben pagata. Il cantiere durò dall’agosto al novembre del 1841: la prima parete della Palatina - la prima parete, niente più - sarebbe stata portata a termine solo nel 1842.
Ancora a encausto e in tempi rapidissimi era stata realizzata, sempre nello stesso lasso di tempo, un’altra delle committenze ufficiali dello Scaramuzza, la volta della Sala del Medagliere del Museo di Antichità, iniziata nel marzo del 1844 per un compenso di 4000 lire e con l’impegno di concludere i lavori al massimo entro un anno. La raffinata decorazione del soffitto era stata voluta di tipo antiquario, caratterizzata da effetti illusionistici di finti stucchi a grisaille, fregi di gusto archeologico, medaglioni che imitano il bronzo e altri virtuosismi pittorici in cui la citazione di modelli aulici del passato non si riferisce alla mistica dei primitivi né si nutre di temi religiosi ma è semplicemente neoclassica, in linea con gli indirizzi accademici della Restaurazione. Al centro del soffitto e sullo sfondo di un cielo dalla tonalità azzurra lucida e brillante, quasi metallica, appare la raffigurazione allegorica dell’archeologia. Programma complesso sia dal punto di vista iconografico che concettuale, celebrava le quattro civiltà - egizia, etrusca, greca, romana - che costituiscono l’oggetto dell’archeologia, e i suoi eroi, Champollion, Lanzi, Winckelmann, Visconti. Tutt’altra storia rispetto alle pareti della Sala Dante, in cui il disinteresse della committenza la fa sembrare una concessione, un cadeau fatto all’artista perché potesse - senza troppa spesa, impegno per la corte o senza intralciare le altre più importanti realizzazioni -, sfogarsi nella sua personale ossessione.
Trattandosi ancora di Commedia, non meno difficile fu la vicenda delle tavole, i 243 disegni che ne illustrano gli episodi salienti (73 per l’Inferno, 150 per il Purgatorio e 50 per il Paradiso) e che nel 1865 avrebbero dovuto celebrare i 600 anni dalla nascita di Dante. Commissionati nel 1859 da Luigi Carlo Farini, «dittatore delle province Parmensi», finirono vittime delle incertezze politiche. Rimasero a lungo incompiuti, eseguiti in gran parte per conto proprio dall’artista a causa dell’inaffidabilità della committenza. Vennero parzialmente esposti in una serie di mostre itineranti tra Parma e Milano nel 1872 e completati solo nel 1876, ma ormai troppo tardi se si considera che nel 1861 Gustave Doré era diventato, con le sue illustrazioni dell’Inferno, una celebrità. A tal punto in ritardo arrivò il pittore parmigiano, che il suo capolavoro rimase per circa un secolo sepolto nel fondo di un baule finché non venne rocambolescamente riscoperto dai suoi discendenti, che poterono metterlo in salvo per miracolo dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
Oltre le difficoltà di esecuzione, in cosa è caratteristica, dunque, la produzione dantesca di Scaramuzza? Probabilmente di quegli stessi principi teorizzati da Schlegel e visti all’opera negli anni romani, per cui attraverso la Commedia il pittore poteva riesumare artisticamente, ovvero perseguendo un’estetica di natura percettivamente mistica, la spiritualità medievale. Scaramuzza si distinse dagli altri illustratori per una profonda conoscenza delle tre cantiche e il fascino subito per la sublime e potente visione immaginativa di Dante, al punto da dare forma a un’opera assolutamente originale per quantità di illustrazioni e qualità dei disegni, non a caso caratterizzati da un’assoluta fedeltà al testo poetico. Con lui si ebbe una vasta esegesi estetica degli elementi narrativi e delle allegorie dei Canti, tracciata con tecnica di notevole complessità ed efficacia, in cui la penna vibra, quasi anticipando la tecnica divisionista, trascrivendo per gli occhi la varietà delle scene letterarie, la cosmologia dantesca e il suo ordinamento morale, echeggianti un universo di analogie con qualsiasi possibile presente.
Alla diffusione di un irrazionale borghese, perfettamente coerente con una società instabile e affamata di speculazione come quella, Scaramuzza non fu indifferente, ma si fregiò di qualità medianiche che sosteneva utilizzasse in pittura. Non si fa fatica a pensare alla sua concezione artistica come a una complessiva attività di riesumazione, in effetti, ovvero di svelamento della radice spirituale della storia per cui, cogliendo alla lettera l’invito del cardinale bolognese Giovanni Battista Caprara, che nel 1806 aveva introdotto il culto di san Napoleone Martire per poter officiare un giorno l’anno in reverenza all’imperatore, si era prestato per un Oratorio di Sala Baganza a dargli le fattezze di Bonaparte, espressione provvidenziale del presente storico. L’artista come medium sembrerebbe dunque l’idea che aveva Scaramuzza del romanticismo, «nato per sentire Dante», per cui, come scrisse Alberto Rondani: «Quando per contro alzo gli occhi dalla pagine del poema e li porto sui disegni del pittore parmigiano, egli è come se continuasse a leggere nella Divina Commedia; continua in me la stessa illusione; poiché le figure messemi innanzi dal pittore si muovono, operano, sentono, come nel poema».
L’atmosfera mistica in cui il pittore concepì le sue opere trovò a Parma terreno fertile anche presso altri letterati e nobili locali, tra cui Jacopo Sanvitale, che condivisero con lui la fede nello spiritismo inteso come scienza nuova, «positiva». L’amore per la Commedia e la fede nelle qualità medianiche sono, dunque, in Scaramuzza parte di una visione esistenziale propriamente romantica, creatrice in alcuni dei sui dipinti religiosi, come l’Assunzione di Cortemaggiore o l’Immacolata Concezione di Ziano Piacentino, occupate da visioni superiori e illuminate da un sentimento di intensa spiritualità. La vocazione all’incontro con i grandi poeti del passato non si limitò a Dante ma si rivolse anche a Petrarca, Ariosto, Metastasio, di cui egli si sentì chiamato a essere il tramite, al punto da farsi strumento di supposte opere post mortem. Ecco quindi apparire le Poesie spiritiche del 1866, un Poema sacro dettato dallo spirito di Ludovico Ariosto al medio Francesco Scaramuzza del 1873 e il Saggio di Commedie scritto suo tramite da Carlo Goldoni nel 1873. Non sorprenderanno di certo i Due canti sulle corporali esistenze dello spirito dettati da Dante Alighieri nel 1875, la cui scarsa qualità letteraria venne motivata con il fatto di essere solo un «medio», non necessariamente un buon trascrittore.
È una vera fortuna se il Complesso Monumentale - che già nell’area detta della Rocchetta conserva uno dei primi allestimenti del Romanticismo italiano - racchiude dentro di sé un documento così significativo, ovvero il primo ciclo consacrato alla dantemania di un artista italiano e che in occasione dell’importante centenario dantesco che ricorre nel 2021 possa esporre all’interno dei suoi spazi, in un dialogo ideale con gli affreschi, l’intero nucleo dei disegni per la Commedia realizzati da Scaramuzza. In grandissimo ritardo rispetto all’Europa, certo, ma quasi un’avanguardia in riferimento a una riscoperta italiana che sarebbe esplosa solo venti anni più tardi, ovvero nel 1865, in occasione dei 600 anni dalla nascita del poeta, quale mezzo di sottolineare, attraverso la sua figura, l’elezione di Firenze a capitale. In quella circostanza la penisola andò cercando un suo Goethe, eroe della lingua quale elemento identificativo del suo popolo, e pensò di averlo trovato. Una ricerca velleitaria che si tradusse nella fondazione di innumerevoli comitati danteschi, più tardi ancora nella nascita degli istituti culturali in giro per il mondo, ma che non riuscì mai a trovare il suo simbolo, come testimonia la storia paradigmatica di una statua che avrebbe dovuto, su progetto di Cesare Laurenti, essere collocata su Monte Mario - proprio come quella di Goethe nel 1844 a Francoforte -, e che non vide mai la luce. Nel frattempo, una nazione tentennante e ingenerosa destinava - ma davvero a lungo, ovvero fino alla rivalutazione dei tempi recenti - uno dei suoi pittori e il suo meraviglioso ciclo dantesco a un immeritatissimo flop.
Il testo è uno dei saggi inclusi del volume
«SCARAMUZZA. Le tavole per la Divina Commedia»
edito dalla Società editrice Allemandi
Leggi anche
SCARAMUZZA TRA REALTA' E VISIONI di Vittorio Sgarbi
L'IMPRESA DI SCARAMUZZA di Carlo Ossola
LA COMMEDIA DI DANTE TRADOTTA IN IMMAGINI di Lina Bolzoni

Altri articoli dell'autore
Il direttore Simone Verde rintraccia le origini dell’attrazione del Romanticismo europeo per l’Alighieri e ricorda che il culto del Sommo Poeta nell’800 si affermò all’estero anziché in patria