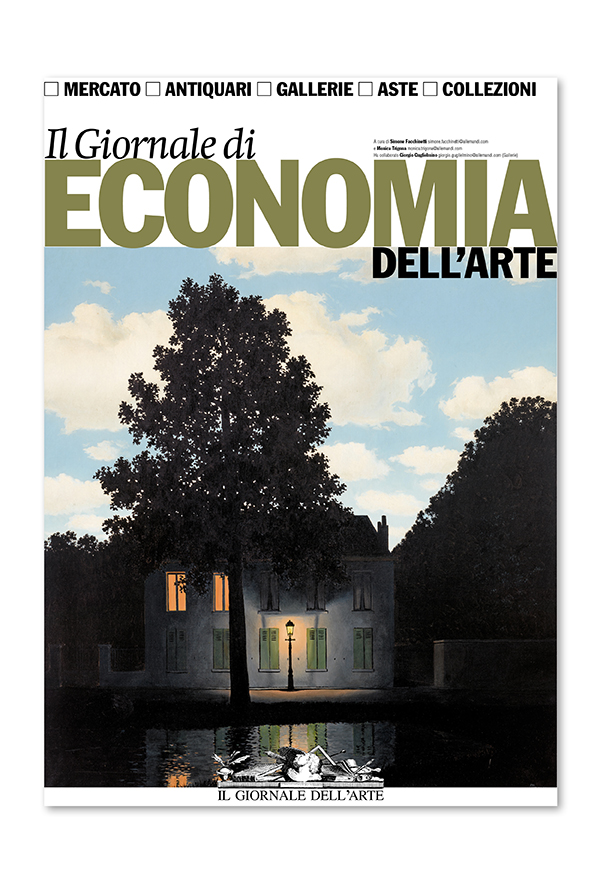Franco Fanelli
Leggi i suoi articoli«Nella mia carriera ho ricoperto tutti i ruoli, da ministro a direttore dei Musei Vaticani: ma il “mestiere” che più ho amato è il soprintendente, una figura fondamentale che però, nella riforma Franceschini, non si sa bene che cosa sia»
«Una sorta di premio alla carriera: così, nel 2007, interpretai la nomina alla direzione dei Museo Vaticani. La chiamata di Benedetto XVI Ratzinger, uno studioso che conosce l’arte italiana come e forse meglio di me, arrivava quando ero già in pensione dall’amministrazione dei Beni culturali, dopo essere stato soprintendente, dal 1980, a Venezia, Verona e Mantova e per quasi vent’anni a Firenze»: Antonio Paolucci, a 77 anni, ha attraversato da protagonista assoluto e in diversi ruoli tutte le vicende che dagli anni Settanta a oggi hanno riguardato il patrimonio artistico italiano. Tra il 1995 e il 1996 è stato anche ministro dei Beni culturali e ambientali nel governo Dini: primo e sinora unico tecnico in quel dicastero, una sorta di paradossale anomalia nel nostro sistema politico. In quella posizione manifestò, da autentico «eretico e profeta», il suo dissenso circa la gestione manageriale dei beni culturali. Ora si prepara a lasciare anche i Musei Vaticani (il «museo dei musei», come li definisce lui), «accompagnando» sino alla fine del 2016 Barbara Jatta, già responsabile del Gabinetto delle Stampe della Biblioteca Apostolica Vaticana e ora vicedirettrice di Paolucci, alla definitiva successione.
Professor Paolucci, quali Musei Vaticani lascia?
Come direttore, il problema più importante che ho dovuto affrontare è stato quello della pressione umana, delle tante persone che ogni giorno percorrono i musei del papa: in piena stagione turistica siamo tra i 18mila e i 20mila ingressi giornalieri, che significano 6 milioni di visitatori annuali. È come dire che ogni anno la popolazione di un Paese come la Svizzera si rovescia nei Musei Vaticani e in qualche modo li «pettina», li consuma. Ho tentato di risolvere questo problema come meglio sapevo. Intanto con il sistema delle prenotazioni online, perché ormai i grandi musei come gli Uffizi, il Louvre o il Metropolitan si possono governare soltanto con questo tipo di prenotazione. Ci sono ancora le code naturalmente perché c’è sempre quello che all’ultimo momento spera di entrare, ma il 70% dei visitatori dei Musei Vaticani entra attraverso la prenotazione, e questo significa un grosso vantaggio perché permette di modulare e razionalizzare meglio i flussi. Però bisognava anche intervenire, e questa è la cosa che mi rende particolarmente orgoglioso, sulla messa in sicurezza dal punto di vista ambientale dei più grandi capolavori dei Musei Vaticani, in particolare la Cappella Sistina. Chi viene a Roma, da qualsiasi parte del mondo, vuole vedere soprattutto due cose: il Colosseo e la Cappella Sistina. Così due anni fa abbiamo messo a punto un sistema di climatizzazione per il ricambio dell’aria, il controllo della temperatura e dell’umidità e soprattutto per l’abbattimento dell’anidride carbonica prodotta dalla respirazione di 2mila persone tutte insieme. Si stavano infatti innescando processi degenerativi sugli affreschi non solo di Michelangelo, ma anche di Perugino, Botticelli, Ghirlandaio ecc. E poi ho fatto altre cose di cui sono contento.
Per esempio?
Ho istituito all’interno dei Musei Vaticani l’ufficio del conservatore, che monitora lo stato di salute delle collezioni, anche quelle conservate nei depositi, e indica di volta in volta le provvidenze necessarie; ho anche attivato un servizio di manutenzione ordinaria continua, utilizzando dieci restauratori reclutati tra professionisti usciti dai laboratori e dalle scuole di restauro italiani, che per tutto l’anno, tutti i giorni provvedono alla manutenzione ordinaria, alla spolveratura, al controllo delle opere esposte. Ho inoltre aperto i Musei Vaticani ai percorsi formativi, quelli che tutti chiamiamo stage: ogni anno per la durata di sei mesi, quindi in due turni, dai 20 ai 25 ragazzi italiani e stranieri sono accolti nei Musei, nei vari settori si formano a contatto diretto con la vita di un grande museo.
Insieme agli stranieri, gli italiani affollano i musei e le mostre. Ma circa la reale sensibilità del pubblico italiano (e dei suoi governanti, di cui parleremo più avanti) nei confronti dei beni culturali cito da un suo articolo pubblicato sul «Corriere della Sera» nel dicembre 1995, quando lei era ministro. Il titolo era: «Beni culturali, il paradiso perduto». E lei scriveva: «In realtà i governi e la classe politica altro non hanno fatto se non registrare l’insensibilità degli italiani per il loro patrimonio storico. Per gli italiani le colonne, gli archi, i dipinti e le sculture, le biblioteche e i musei valgono lo 0,19% del bilancio nazionale e della loro attenzione». È cambiato qualcosa?
Io sono il decano degli storici dell’arte italiani che si occupano di tutela nei musei. Quindi credo di conoscere bene il popolo dei musei. L’ho studiato a Venezia, Mantova, Firenze, ora a Roma in Vaticano. La gente che fa la coda per vedere «La Primavera» del Botticelli, la Cappella Sistina o «La Gioconda» (che poi non vedrà mai perché ha una muraglia di persone davanti a sè) è composta da persone che per il 90% non ha mai letto un libro, guarda soltanto la televisione e non riuscirebbe nella sua lingua madre a scrivere una riflessione di dieci righe senza fare errori. Questo è il popolo dei musei ed è lo stesso popolo che vota. Ma questa è la democrazia dei consumi, l’unica che esiste sotto il cielo. Oggi chiunque può pagarsi un ingresso al Louvre o ai Musei Vaticani ed è bello che questo sia possibile, ma pretendere che la gente che esce dai Musei Vaticani o dal Louvre ricordi qualcosa di quello che ha visto o che abbia capito quello che tutti noi vorremmo avesse capito è un po’ un’utopia. Noi dobbiamo esserne consci, dobbiamo confrontarci con questo tipo di pubblico. Non è più il tempo in cui nei musei dell’Europa e del mondo entravano le élite, gli intellettuali oppure i milord inglesi o i russi: per fortuna, dovremmo dire.
Come migliorare la situazione?
Dovremmo lavorare soprattutto sull’educazione, convincere la gente che sì, è giusto andare in America a vedere il MoMA o a Parigi a vedere il Louvre, ma che prima di fare queste cose dovrebbero visitare il museo civico della loro città. Chi abita a Viterbo, prima di andare a New York, vada nel Museo Civico a vedere la «Deposizione» di Sebastiano del Piombo con quella luna shakespeariana dietro la Madonna che tiene sul grembo il figlio morto. E questo vale per tutta l’Italia. Ecco il tipo di educazione preventiva che io vorrei (e ho scritto tanto su questo argomento e tanto me ne sono occupato nella mia carriera): che le persone cominciassero l’educazione all’arte dall’ombra del proprio campanile; ma è soprattutto la scuola che deve compiere questa operazione.
In tal senso lei è un eccellente divulgatore e lo dimostra anche con le sue presenze televisive. Direi che la capacità di comunicare non è così comune tra gli storici dell’arte, della sua e di altre generazioni.
La divulgazione televisiva l’ho sempre fatta. Mi piace, credo sia utile. E poi credo di saper parlare di certe cose, di riuscire a trasmettere quello che emoziona per primo me stesso. Questo dovrebbe essere il dovere di un insegnante, cioè trasmettere, prima dello specifico della cosa di cui parla, l’emozione, lo stupore che prova lui di fronte a quella cosa.
Non ha mai pensato a una carriera universitaria?
Mi sono laureato con Roberto Longhi, che mi avrebbe voluto come suo assistente. Subito dopo la laurea dovetti sottopormi al servizio militare. Al mio ritorno, con la morte di Longhi anche la situazione «politica» era cambiata e quindi a quel punto, considerato che non avevo scenari universitari davanti a me, ho sostenuto il concorso per entrare nell’amministrazione dei beni culturali. Se giudico da quello che sarebbe accaduto dopo, ho fatto bene.
Che cosa le ha insegnato in particolare Roberto Longhi?
Mi ha insegnato a guardare l’opera d’arte dal punto di vista tecnico, cioè a conoscere l’arte nella sua realtà fisica, nella sua letteratura, nella sua storia attributiva, nelle sue vicende museografiche, collezionistiche ecc. Ma da lui ho anche imparato a «giocare» sempre di fronte ai valori considerati assoluti, alle idee tramandate da quelli che sono venuti prima, a essere sempre spregiudicato: mi ha insegnato la capacità di dissentire dalle idee «fatte», dalle convinzioni consolidate. Ho ereditato una libertà mentale nell’approccio critico, accompagnata però da una conoscenza reale, tecnica concreta dell’opera d’arte. Io devo molto a Longhi, così come devo molto alla mia famiglia: faccio questo mestiere perché vengo da una famiglia di antiquari. Quindi fin da bambino ho imparato ad amare l’odore delle cose antiche e questo è stato il mio destino, non avrei potuto fare un altro mestiere.
L’Italia vanta ancora una posizione di primato nel restauro?
Io fra l’altro nella mia carriera sono stato anche restauratore, in qualità di soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure. Il restauro è tra i pochissimi primati che ancora restano all’Italia nel mondo. Basti pensare che l’opera principale sulla teoria del restauro, il testo di Cesare Brandi, è tradotta in tutte le lingue del mondo e che se si va al Metropolitan Museum di New York o a Xian in Cina si vedono all’opera restauratori italiani. Come l’inglese è la lingua franca nella medicina, così l’italiano lo è nel campo del restauro: questo vorrà pur dire qualcosa, questo c’è rimasto e devo dire che ancora, con tutti gli immensi problemi che hanno, l’Istituto Centrale per il Restauro di Roma e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze sono due capisaldi fondamentali della nostra disciplina e della tutela.
Lei vent’anni fa è stato ministro ai Beni culturali. Già all’epoca, però, avvertiva certi rischi. Tornando all’articolo prima citato, scriveva: «Per quanto marginale, il nostro era ed è un ministero di frontiera, occupava e occupa spazi di confine tali da incoraggiare sperimentazioni anche rischiose. Negli ultimi tempi molti hanno visto in questo ministero una specie di campo virtuale suscettibile di chissà quali misteriosi sviluppi economici, occupazionali, di immagine».
Io ho fatto il ministro in un’epoca che dal punto di vista della politica è il Paleolitico rispetto a oggi; è cambiato tutto, è cambiato il mondo, è cambiata l’Italia. In quel tempo c’erano ancora grandi e forti illusioni. Credevo, e non ero il solo, nel progetto di Spadolini, che istituì il Ministero per i Beni Culturali, di un museo autonomo che potesse interfacciarsi con altri e portare avanti il primato italiano della cultura. Poi le cose sono andate come sappiamo, ha prevalso la cultura americana, si è affermata sempre di più l’idea dell’economicità della cultura, l’idea della produttività del patrimonio in termini di occupazione, quindi di reddito, cose che poi si sono dimostrate non vere. Eppure questa ancora oggi è la cultura dominante nel nostro campo, e questa è stata la delusione provata dalla mia generazione. Ma, per citare il titolo del film di Martone, «noi credevamo».
In termini di valorizzazione, Alberto Ronchey, che la precedette al Ministero, in un certo senso fece propria la definizione dei beni culturali come il petrolio italiano…
La valorizzazione, e questo è il pensiero di uno che lavora nelle belle arti da 50 anni, nasce dalla conoscenza, quindi si valorizza conoscendo noi per primi e facendo conoscere agli altri, questo è il punto. Oggi si intende la valorizzazione come messa sul mercato ed è un’altra cosa. Ronchey, grande giornalista, veniva da una cultura americanizzante e a quell’epoca quello che diceva sembrava assolutamente rivoluzionario e innovativo. Ma Ronchey fece anche delle cose buone, per esempio fu il primo a dire che l’uso del patrimonio figurativo come fotografie e riproduzioni di opere nei musei dovesse essere pagato; e fu il primo, in Italia, ad affermare il principio che all’interno del museo ci dovesse essere un posto dove potere prendere un caffè o comprare un libro, una pubblicazione, una cartolina. Prima di Ronchey i visitatori dei musei italiani, se volevano comprare una cartolina da mandare alla fidanzata, dovevano rivolgersi agli ambulanti in piazza come nella Siria o nella Turchia degli anni Trenta.
Qual è stata negli ultimi tempi la peggiore legge per i Beni culturali in Italia?
La riforma Franceschini, l’ho detto e scritto in molte occasioni e lo confermo una volta di più, è quella che secondo me ha disarticolato realtà che dimostravano di funzionare più o meno bene, ma funzionavano. Tutto ciò in vista di una palingenesi che poi in realtà non c’è. Con questa riforma non si capisce più chi siano i soprintendenti, che cosa facciano.
E quale la migliore?
Per quanto riguarda la legge migliore, non posso invece riferirmi ad anni recenti. È un provvedimento che risale al 1515, ma è una legge importantissima simbolicamente e politicamente: parlo di quando il papa Leone X Medici nominò Raffello praefectus marmorum et lapidorum, praticamente soprintendente di Roma. Per la prima volta nella storia, un sovrano, un capo di governo, afferma il principio che la potestà normativa e prescrittiva sui beni culturali deve essere esclusivamente affidata alla competenza tecnica. Raffaello era il miglior «tecnico» in quel momento sulla piazza; il papa avrebbe potuto nominare soprintendente di Roma un suo parente, un suo amico, un suo sostenitore, invece afferma questo principio. A occuparsi di belle arti ci vuole chi di questa roba se ne intende.
Che ne è del progetto Grandi Uffizi?
Sta andando avanti, e intanto rimane aperto il problema della nuova uscita progettata da Arata Isozaki. Un problema che secondo me non si risolverà mai. Nel 1998 venne indetto un concorso internazionale al quale parteciparono, tra gli altri, Gae Aulenti, Vittorio Gregotti, Norman Foster e lo stesso Isozaki. Venne creata una commissione; ne facevo parte io, in quanto a quell’epoca soprintendente al Polo Museale Fiorentino, Annamaria Petrioli Tofani, in quanto direttrice degli Uffizi, e Mario Primicerio, allora sindaco di Firenze. Io personalmente propendevo verso la proposta Gregotti; se l’avessero scelta non ci sarebbero state polemiche perché il suo era un progetto accettabile per una città come Firenze, non particolarmente originale forse, ma correttamente modulato sui colori e sulle caratteristiche della città. Invece per un soprassalto di modernismo esterofilo, la commissione a maggioranza scelse Arata Isozaki, che per carità è un grande architetto e ha progettato questa grande loggia fuori scala che allude alle logge di Firenze, cosa che scatenò, tra gli altri, le polemiche di Vittorio Sgarbi.
Siete sempre amici lei e Sgarbi?
Siamo amici e continuiamo a esserlo proprio perché non abbiamo mai fatto niente insieme.
Sarebbe un buon ministro per i Beni culturali?
Penso di no, lasciamogli fare il mestiere che sa fare benissimo, cioè quello di storico dell’arte perché è bravo e nessuno può negarlo, e anche di polemista che spesso spara nel mucchio e a volte sbaglia il bersaglio altre lo centra.
Un polemista assai attivo è oggi Tomaso Montanari…
È un buono storico dell’arte, questo sì, i suoi studi su Bernini sono eccellenti. Ma adesso si occupa più che altro di politica e su questo non lo seguo più. Io faccio un altro mestiere.
Se dipendesse da lei, chi sceglierebbe come ministro?
Salvatore Settis. Ha sensibilità e cultura «politica», cosa irrinunciabile. Ma allo stesso tempo conosce e pratica i mestieri e i saperi delle arti: l’archeologia, la storia dell’arte, la catalogazione del patrimonio, le specializzazioni del restauro.
È soddisfatto della formazione degli storici dell’arte oggi in Italia?
No. Non mi sembra che ci siano i maestri della mia generazione, non riesco a vederli in giro, gli Arcangeli, i Volpe, i Bologna, le Griseri... Voglio dire che il décalage dei livelli accademici si nota dappertutto. Resta tuttavia il fatto che l’Italia, con le sue università e i suoi musei, per uno che voglia fare il mestiere dello storico dell’arte è la base di partenza irrinunciabile, fondamentale. È qui che uno impara veramente il mestiere, poi vada pure all’estero, vada a fare perfezionamenti e stage in America, in Germania o altro, ma è qui, girando per le chiese, per i paesi dell’Italia, visitando i depositi dei musei, è qui che si diventa storici dell’arte.
Quali incontri per lei sono stati particolarmente importanti?
Sono state importanti molte persone che hanno fatto parte delle mie esperienze e della mia carriera. Federico Zeri, ad esempio, è un uomo che ho frequentato, che mi è stato amico. Poi più in generale, tutti i miei colleghi delle Soprintendenze, donne e uomini che avevano le mie stesse idee e che partecipavano del mio entusiasmo. Ecco, se dovessi immaginare una cerimonia di congedo dalla carriera vorrei avere intorno tutte le colleghe e i colleghi che a Venezia come a Mantova, Firenze, Roma, come al Ministero del Collegio Romano hanno avuto a che fare con me, hanno fatto il mio stesso mestiere, condiviso le mie speranze e i miei entusiasmi.
Ha qualche rammarico?
Quello di non essere riuscito, quando ero ministro, ad assicurare all’Italia la Collezione Torlonia. Poi ho visto che in seguito le cose si stavano in qualche modo aggiustando, ma vent’anni fa con il vecchio principe, Alessandro Torlonia, con Antonio Giuliano, archeologo, e con lo stesso Sgarbi eravamo molto vicini alla soluzione.
Lei è un irriducibile sostenitore della conservazione e della necessità dei musei, ma l’Italia è diventata un mostrificio…
Il fatto è che la mostra è diventata un mestiere, fa lavorare allestitori, architetti, trasportatori, restauratori, interessa ai politici perché un qualunque assessore facendo una mostra almeno una mazzetta di ritagli stampa se la guadagna e questo è un fenomeno che credo sia diventato irreversibile, non c’è dubbio. Gli stessi storici dell’arte nel catalogo di una mostra possono pubblicare cose che nessun editore mai pubblicherebbe, ma lì ci possono schiaffare 110 cartelle. C’è una conventio generale ad mostrandum.
In quale ruolo si è sentito più a suo agio? Come ministro, come direttore di museo o come soprintendente?
Come visibilità mediatica naturalmente essere direttore dei Musei Vaticani non c’è partita con nessun altro ruolo, ma il mio vero mestiere, quello che quando ero giovane ho fatto divertendomi sul serio ed essendo felice di farlo è stato il mestiere di soprintendente e di restauratore, cioè quando sono stato soprintendente nel territorio, a Mantova, Cremona, Brescia, Vicenza e Belluno, oppure quando lo sono stato all’Opificio delle Pietre Dure, e avevo sotto mano i restauri sul Crocifisso di Giotto di Santa Maria Novella oppure sulla pala di Coppo di Marcovaldo al Carmine. La felicità per me sta in questi mestieri, ma io ho percorso tutti i gradi della carriera, da caporale a generale di corpo d’armata.
Non le sarebbe piaciuto dirigere un museo straniero?
Non ne ho mai avuto l’opportunità, nessuno me l’ha mai chiesto.
Non le è mancato lo studio in tutti questi anni?
Mi è mancato molto lo studio nell’ultimo periodo. Adesso avrò tempo di rimediare.
È difficile pensarla in pensione.
Io ho il mio studio a Firenze, dove conservo i miei libri; e a Firenze ho una casa e una famiglia, ho un sacco di amici, di relazioni, di occasioni, di inviti. Se Dio vorrà, continuerò a fare il mestiere che ho sempre fatto, quello di storico dell’arte.
Vorrei concludere questa conversazione parlando di un argomento controverso, quello sui non semplici rapporti tra arte contemporanea e arte sacra.
Una cosa di cui sono molto contento è che nei miei nove anni di direzione la Città del Vaticano è stata presente due volte alla Biennale di Venezia e questo vorrà pur dire qualcosa. I Musei Vaticani hanno un dipartimento di arte moderna e contemporanea voluto e inaugurato nel 1973 da quel grande intellettuale cattolico del Novecento che è stato papa Paolo VI Montini. I Musei Vaticani hanno sempre avuto una speciale attenzione per la cosiddetta arte sacra, anche se oggi non si usa più quest’espressione.
Ma l’arte contemporanea riesce ancora ad avere un dialogo con la Chiesa Cattolica? Si vedono in giro certi obbrobri…
Checché ne dica il cardinale Gianfranco Ravasi, mio carissimo amico, questo è una speranza, ma non mi pare che oggi come oggi funzioni. Si possono solo gettare dei semi, stimolare delle attenzioni, aspettare, anche perché io ho un’idea molto chiara sull’arte contemporanea.
Cioè?
Penso che il nostro momento storico sia quello della decomposizione, della frantumazione di tutti i linguaggi figurativi. È grande il disordine sotto il cielo; bisogna però immaginare che tutti questi materiali del contemporaneo saranno il concime dal quale nasceranno il Raffaello, il Michelangelo del XXII, XXIII secolo. E magari nasceranno in Cile piuttosto che in Australia: noi abbiamo già dato. D’altra parte questo è già successo nella storia; pensi se fossimo vissuti nel Duecento: non c’era più il latino, non c’era ancora l’italiano, i poeti usavano linguaggi artificiali, il provenzale, la lingua d’oc, e poi da tutta questa confusione viene fuori Dante Alighieri che scrive «La bocca mi baciò tutto tremante» che sembra una canzonetta di Sanremo invece è il canto di Paolo e Francesca. La caratteristica dell’uomo è di avere tante qualità, la creatività, la fantasia, ma non ha il dono della profezia. Non possiamo immaginare le variabili imprevedibili della storia. Quando ero giovane tutti credevamo che il mondo sarebbe stato per sempre diviso dalla contrapposizione fra il blocco sovietico e l’Occidente libero e che forse tutto si sarebbe risolto o con l’armageddon atomico oppure con l’equilibrio del terrore. E invece, un giorno dell’anno 1989 il comunismo si è sciolto come la neve dai tetti dopo una notte di pioggia. Chi poteva prevederlo?
Purtroppo ci sono anche sorprese negative.
Sì, quando ero giovane, pensavo, come pensavano tutti, che le religioni fossero un fatto residuale, relitti che il progresso, la tecnologia avrebbe dissolto, evaporato, e invece oggi ci troviamo di fronte a uno scontro di civiltà e di religione. Anche questo era imprevedibile.
Lei ha tuonato anche contro l’architettura delle nuove chiese.
Gli architetti possono anche essere bravi, ma è evaporata l’idea di chiesa in senso architettonico. Le chiese nuove somigliano a garage, supermercati, discoteche, a luoghi assembleari, cosa che non è successa altrove, perché se noi attraversiamo la Turchia reislamizzata vediamo che sorgono dappertutto moschee nuove, fatte con materiali scadenti, di cemento, di plastica, di latta, tuttavia riproducono più in piccolo, magari anche in brutto, le moschee sultaniali di Bursa, di Costantinopoli, di Adrianopoli. E lo stesso si può vedere in Russia, almeno da quando Putin è diventato devoto e si fa fotografare con la candelina in mano. Un fedele, in questi casi, riconosce la chiesa; da noi non è più così, per fortuna ci sono le chiese antiche.
È ancora convinto che la grande arte italiana sia finita con Tiepolo, come dichiarò, non senza scatenare prevedibili polemiche, nel 1996?
Beh, dissi una cosa tutto sommato banale. C’è stato un periodo in cui la lingua figurativa del mondo era l’italiano, gli artisti venivano a studiare a Firenze e a Roma, Raffaello era il modello per tutti, la scuola dei maestri. Questo è durato più o meno fino all’Illuminismo, poi i termini della questione sono cambiati, anche se l’Italia col Futurismo ha giocato ancora un ruolo internazionale, l’ultimo sussulto di internazionalità dell’arte italiana.
Ha ancora senso parlare di appartenenze nazionali nell’arte?
Credo di no. Ma in tempi calamitosi come quelli in cui siamo stati chiamati a vivere, credo che, e qui è lo storico dell’arte che parla, un dovere ce l’abbiamo, quello di conservare le nostre testimonianze identitarie. Questo lo dobbiamo pur fare, poi succeda quel che succeda; ma che agli Uffizi ci sia Botticelli e che la Cappella Sistina viva anche tra un secolo è un dovere irrinunciabile. E io a questo ho dedicato la vita.

Antonio Paolucci
Altri articoli dell'autore
Artista, bibliotecario, insegnante privato di francese, organizzatore e geniale allestitore di mostre: il suo celebre orinatoio capovolto è stato considerato l’opera più influente del XX secolo. Usava lo sberleffo contro la seriosità delle avanguardie storiche, e intanto continuava a scandagliare temi come il corpo, l’erotismo e il ruolo dello spettatore
Mercato e passione: l’anima di una fiera ricca di scoperte, non solo per collezionisti, ma per l’intero sistema dell’arte. Ne parla il direttore Luigi Fassi
A 92 anni l’artista tedesco è uno dei più ricchi e più imitati del mondo. I suoi ammiratori lo indicano come l’unico erede possibile degli antichi maestri, un pittore il cui vero soggetto è la pittura stessa, ma c’è anche chi sospetta che il suo trasformismo stilistico sia una strategia commerciale capace di sfruttare e di estetizzare anche l’Olocausto
Curato da Giuseppe Appella, esce il monumentale Catalogo generale di un artista-umanista «prosecutore di una tradizione rinascimentale»