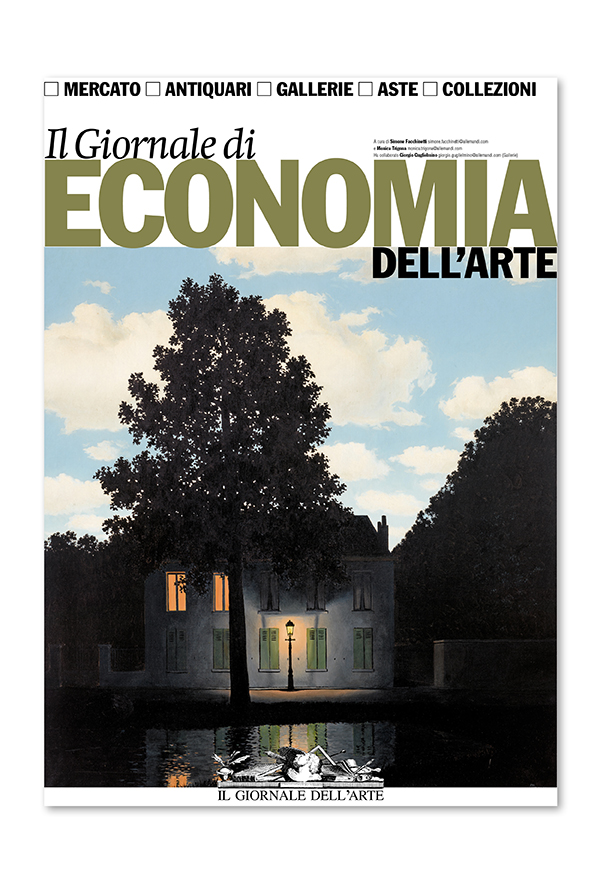Alexander Morrison
Leggi i suoi articoliL’artista britannico-ghanese John Akomfrah (Accra, 1957) si è spinto oltre i confini del cinema per più di quattro decenni. Dopo aver iniziato con documentari sperimentali come «Handsworth Songs» (1986), che analizza le rivolte razziali britanniche dei primi anni Ottanta, negli ultimi anni si è dedicato soprattutto a installazioni multischermo riccamente stratificate che esplorano temi come il cambiamento climatico, il colonialismo e il tempo. Il lavoro di Akomfrah è intensamente collaborativo; ha cofondato il Black Audio Film Collective nel 1982 e poi Smoking Dogs Films nel 1998.
L’anno scorso è stato nominato cavaliere e rappresenterà la Gran Bretagna alla prossima Biennale di Venezia, mentre nel 2019 ha contribuito al Padiglione inaugurale del Ghana. In vista della Biennale di quest’anno, Akomfrah ha pubblicato un nuovo lavoro, «Arcadia» (2023), esposto prima alla Biennale di Sharjah e ora in forma modificata al The Box di Plymouth, nel Regno Unito, fino al 2 giugno. Il film, proiettato su cinque schermi organizzati a forma di croce, ripercorre la formazione del Nuovo Mondo e mette in evidenza il ruolo svolto dalle migrazioni di persone, merci, piante e malattie (note come «Scambio colombiano». Il termine, coniato dallo storico Alfred W. Crosby, autore nel 1972 del libro The Columbian Exchange, si riferisce a un evento iniziato con il primo viaggio di Cristoforo Colombo verso le Americhe nel 1492 ed è ritenuto da alcuni autori la prima globalizazione, Ndr). In parte una risposta alla pandemia di Covid-19, «Arcadia», come molti film di Akomfrah, lascia anche molto spazio all’interpretazione. E questo, dice l’artista, è esattamente ciò che vuole.
Lei ha detto che le idee alla base del film «Arcadia» sono cambiate molto nel corso del processo di ricerca. Come descriverebbe il prodotto finale a chi lo vede per la prima volta?
Credo che lo spettatore ideale che lo vede per la prima volta dovrebbe pensare: «Sono qui per vedere qualcosa su come si è formato il Nuovo Mondo». E poi pensare: «Oh, ma non è affatto ciò che mi aspettavo». In altre parole, voglio che le persone interessate al dramma dell’avventura coloniale si rendano conto che non tutto è interamente responsabilità degli esseri umani.
La vita non umana è una parte estremamente importante di questo film: l’ho sentita parlare dell’importanza del vento, per esempio. Può chiarirci questo aspetto?
La scoperta degli alisei da parte degli spagnoli e dei portoghesi al largo della costa occidentale dell’Africa ha cambiato le carte in tavola e ha reso possibile il viaggio verso il Nuovo Mondo. Prima di allora, la gente lo sognava, ma non esisteva. Era necessario l’aiuto del vento. Gli alisei sono sempre stati lì, solo che non ce ne eravamo accorti.
Nel film c’è anche un’interessante interazione tra il bello e il minaccioso, come si vede ad esempio nelle immagini piuttosto accattivanti dei microrganismi. È stato completamente plasmato dalla sua esperienza di Covid?
Completamente. L’epidemia di Covid ha fatto la differenza. Le dirò un’altra cosa. Un giorno stavo guardando un programma del tutto insensato su YouTube, con due giovani avventurieri sudafricani in Guatemala che vagano e si imbattono in un luogo in cui escano dal terreno molti scheletri e si chiedono: «Oh wow, com’è successo? Sembrano vecchi!». E all’improvviso ho pensato: «Oh mio Dio, sono in una delle fosse comuni azteche o inca del XVI o XVII secolo, e non ne avevano idea». All’improvviso ho pensato alla narrazione della Mayflower (la nave che trasportò i Padri Pellegrini dall’Inghilterra al Nuovo Mondo nel 1620, Ndr), con i primi resoconti che raccontavano che al loro arrivo non c’era nessuno. Ma la domanda che non ci eravamo posti era: perché?
C’è una frase che si ripete nel film: «la morte, i sogni». Qual è il suo significato?
Cerco di ascoltare molto le voci premoderne. E «morte, sogni» viene dallo scrittore greco antico Artemidoro. Ha scritto un libro che interpreta i sogni e ho pensato che fosse un modo interessante di mettere insieme la narrazione senza essere necessariamente troppo prescrittivo. Perché i sogni di fuga, che hanno ossessionato l’immaginario europeo fin dal XII secolo, da quando iniziano a emergere i codici cavallereschi, sono assolutamente centrali in questa avventura coloniale.
Un termine di cui ha già parlato in passato è «economia affettiva». Lei si preoccupa molto di come le persone si sentono quando vedono il suo lavoro. Come lo descriverebbe in relazione a questo progetto? E c’è un rischio nella narrazione emozionale?
C’è. Ma credo che quello che mi interessa sempre di più sia costruire monumenti che riguardano l’inaugurazione di economie affettive. Tutto qui: inaugurarli in modo che la gente possa esplorarli, entrarvi, provare a percorrerne il labirinto. Non voglio altro, perché credo fondamentalmente che tutti noi abbiamo la capacità, se ci vengono forniti gli strumenti, di camminare da soli nel labirinto della solitudine e decidere se dare un senso, oppure no, a queste cose.
Che effetto le ha fatto proiettare «Arcadia» a Plymouth invece che a Sharjah? So che il progetto è stato leggermente modificato.
Non solo «leggermente». Credo che sia più corto di circa 15 minuti. Alcune sezioni sono state accostate in modo più violento rispetto alla prima versione. Perché inizialmente sentivo di dover rispettare molte narrazioni, ma credo che si possa finire per essere anche eccessivamente rispettosi, e mi è sembrato di essere stato forse un po’ troppo cauto. Mi piace ancora molto l’originale, ma questa seconda versione sembra, per così dire, più adatta al pubblico.
In passato ha detto di voler superare i limiti del cinema. Pensa di essere vicino al limite di questo viaggio?
Quasi tutto in «Arcadia» deve qualcosa al cinema in un modo o nell’altro, ma solo reso leggermente strano, leggermente insolito. Ci sono degli «attori», ma non fanno nessuna delle cose che si suppone facciano gli attori standard. E non sono attori professionisti. La figura principale è il mio scenografo. È lui che indossa un cappotto nero. Si tratta anche di cose su cui la gente si arrovella nel cinema: la storia, la sceneggiatura. Come ho detto probabilmente troppe volte in modo noioso, si tratta di cercare di aggirare le regole aristoteliche del cinema: il senso che deve avere un flusso drammatico e tutto il resto. L’intera faccenda mi annoia a morte.
Gli orologi sono un motivo ricorrente in «Arcadia» e, più in generale, nella sua pratica i confini tra «allora» e «oggi» sembrano regolarmente sfumare. Come vede il tempo, presente e passato, nel suo lavoro?
Cerco sempre più di rilassarmi sui protocolli, sul decoro e sulle convenzioni. Si tratta di coltivare uno stato di impreparazione il più a lungo possibile. Perché non si è mai liberi dai fantasmi, sa? Non posso guardare una scena senza pensare: «Oh, questo è un modo di guardare del regista francese Robert Bresson». Sono completamente contaminato dalla storia di ciò che ho guardato e ascoltato. Quindi lo stato di impreparazione è assolutamente centrale, perché è un modo per dimenticare strategicamente e momentaneamente, o per sognare di essere in questa cosa per la prima volta. E questo è importante, perché altrimenti non succede nulla di nuovo.
Con la Biennale di Venezia alle porte, il suo è un anno importante. Come si prepara a un progetto del genere?
Tutti i progetti iniziano da quello appena finito, letteralmente. Quindi la Biennale avrà molto a che fare con «Arcadia», molto a che fare con le cose che pensavo dovessero essere ulteriormente esplorate da «Arcadia», le cose che pensavo non sono state sufficientemente approfondite, le cose che si sono proposte quando «Arcadia» è finita. Saranno tutti bagagli che porteremo con noi nel prossimo progetto. Quindi i primi incontri con le persone, alcune delle quali sono vecchi collaboratori, saranno all’insegna del «Ti ricordi? Beh, facciamolo, perché in questo non ci siamo riusciti, quindi andiamo lì».

«John Akomfrah: Arcadia» at The Box, Plymouth (2023). Cortesia Sharjah Art Foundation. Foto Shanavas Jamaluddi

John Akromfah. Foto Taran Wilkhu. © British Council
Altri articoli dell'autore
Innuteq Storch, primo fotografo a esporre nel Padiglione danese, porta alla ribalta opere groenlandesi di oltre un secolo fa
I galleristi del nuovo spazio londinese sperano di essere i «successori spirituali» della vicina Lisson Gallery ed espongono opere che potrebbero faticare a ottenere un posizionamento nel mercato
Oggetti che spaziavano dall’arte giapponese a una corona e un mantello rosso di peluche hanno fatto impazzire gli offerenti a New Bond Street