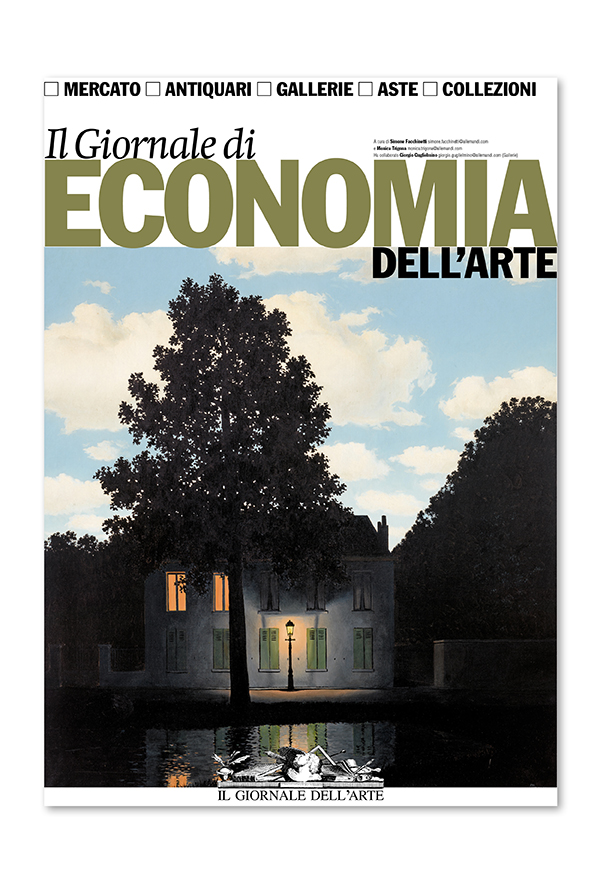Arabella Cifani
Leggi i suoi articoliAntonio Fontanesi (1818-82) è oggi un pittore fuori moda. Fu in auge fino agli anni Novanta del secolo scorso poi, a poco a poco, su di lui è sceso l’oblio. I suoi quadri, che fino a trent’anni fa costavano cifre molto alte oggi si trovano agevolmente, nei formati piccoli, anche sotto i 5mila euro. Non piace più, come molti altri pittori ottocenteschi che aspettano il ritorno del loro astro che potrà venire da un critico che decida di fare una mostra, o da chi dedichi loro qualche studio fondato. Eppure è un grandissimo artista, un poeta a tutti gli effetti.
Fontanesi ebbe una giovinezza misera nella natia Reggio Emilia che gli segnò il carattere. Partecipò alle battaglie risorgimentali del 1848-49, ma fu poi in Svizzera e a Parigi che trovò la sua strada, fra Troyon, Corot, Ravier e la scuola di Barbizon. Errabondo per l’Europa, fu assai stimato a Torino da Cavour e D’Azeglio e, dal 1869, ebbe la cattedra di paesaggio alla Reale Accademia Albertina. Fu anche in Giappone a insegnare per due anni all’Accademia imperiale di Tokyo e ci si rovinò la salute. Inseguiva sogni, non trovava pace, malinconico, inquieto, sempre malaticcio.
Questa sua trepidazione si riflette nelle sue opere migliori, come l’«Aprile» della Galleria d’Arte Moderna di Torino. Il grande quadro, presentato all’esposizione universale di Vienna del 1873 e poi subito acquistato dal governo, è uno dei massimi capolavori del paesaggio ottocentesco italiano anche se a prima vista sembra fatto di nulla. Un salice biforcato erge le sue braccia ancora spoglie (ma le foglie in realtà stanno spuntando) verso il cielo. Dietro di lui una nuvola copre il sole e tutto diviene per un momento incerto e lattiginoso.
Una pianura dei dintorni di Torino, piatta e quasi priva di elementi di vita si estende quasi infinita. Solo due pecore pascolano quiete a sinistra. Mille sottili sfumature fra verde e bruno si avvicendano nella terra e mille sfumature di azzurro e bianco graffiano il cielo. Sentiamo l’odore di questa terra, fatto di piccole erbe amare, e di sostanze animali, di qualche fiore aspro che si affaccia fra le zolle. È la doglia dell’aprile che sta partorendo la nuova vita dei germogli che rompono la scorza, è la fatica del nascere, è la fatica del vivere.
Fontanesi in questo suo quadro-poesia ha espresso, molto tempo prima di T. S. Eliot (1888-1965), che pubblicò La terra desolata, nel 1922, l’idea che «April is the cruellest month, breeding/ Lilacs out of the dead land, mixing/ Memory and desire/, stirring Dull roots with spring rain» («Aprile è il più crudele dei mesi, generando /Lillà da terra morta, confondendo/ Memoria e desiderio, risvegliando/ Le radici sopite con la pioggia di primavera»).
Nel quadro di Fontanesi si assiste in diretta alla nascita delle erbe e delle foglie ma anche al moto del cielo, delle nubi, dei venti. Il quadro ci vorrebbe dare speranza ma in realtà non ne contiene perché è sì l’espressione di un nuovo ciclo delle cose, ma quelle cose appena nate portano già in sé germi della morte. È un’opera che coinvolge emotivamente in modo profondo chi abbia voglia e tempo di sostarci davanti. Dopo un po’ ci si ritrova dentro: il sole è appena tiepido, il nostro passo attutito dalla terra umida e grassa che sta fermentando sotto i nostri piedi. È una Pasqua, è una resurrezione che ci riempie di speranza: forse possiamo mutare le nostre vite misere e smettere di nutrirci di tuberi secchi.
Fontanesi e Eliot si fanno la stessa domanda: i semi avvizziti dell’anno scorso torneranno a germogliare? Fioriranno ancora oppure saranno uccisi da un gelo improvviso? Ricordi e desideri, prima di Fontanesi e poi di Eliot, si possono mescolare. È finito il letargo invernale, ricomincia l’infinito ciclo della rinascita, della fioritura e poi dell’appassimento e della morte di ogni cosa. L’aprile crudele di Fontanesi è un quadro da meditare a Pasqua e ha ancora molto da dirci. Il suo autore, con mezzi che paiono semplici con pennellate sobrie e controllate, senza alcuna distrazione, senza leziosità, ci invita a guardarci dentro e a scrollarci dall’anima la sterilità che ci abita, ci invita a meditare sulla nostra instabile e fragile presenza nel mondo che proprio la simbologia della primavera rappresenta.

«L’Aprile» (1873), di Antonio Fontanesi (particolare). Torino, Galleria d’Arte Moderna
Altri articoli dell'autore
In un nuovo volume edito dalla Fondazione Zeri, Susanna Zanuso passa in rassegna tutti i più bei nomi dell’arte plastica meneghina dell’epoca (Biffi, Prestinari, Rusnati, Bellandi, Vismara, Bussola...), illustrati in una straordinaria campagna fotografica
Lo studio della collezionista francese Nikita de Vernejoul ci restituisce un caravaggesco di alto profilo
La ritrattistica fra Cinque e Ottocento di guerrieri bellicosi, di presunte vedove e di personaggi spesso terrificanti in un ponderoso saggio di Jan K. Ostrowski
Al Fine Arts Film Festival di Venice in California, il film sul pittore emiliano vince il Best Historical feature