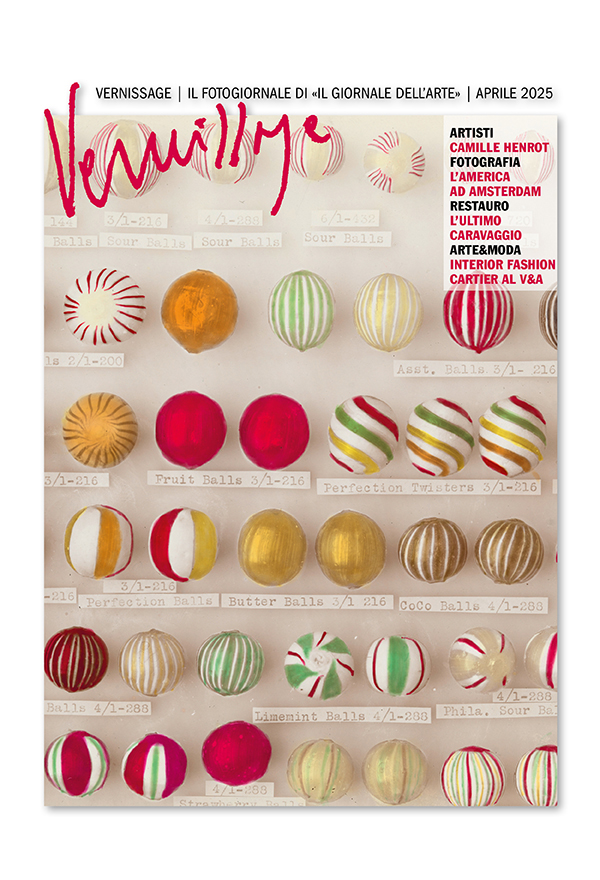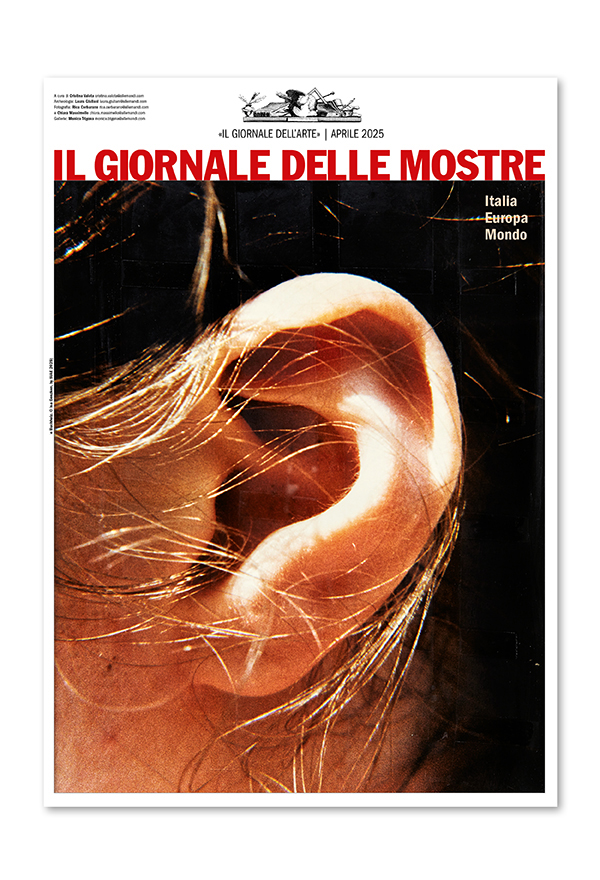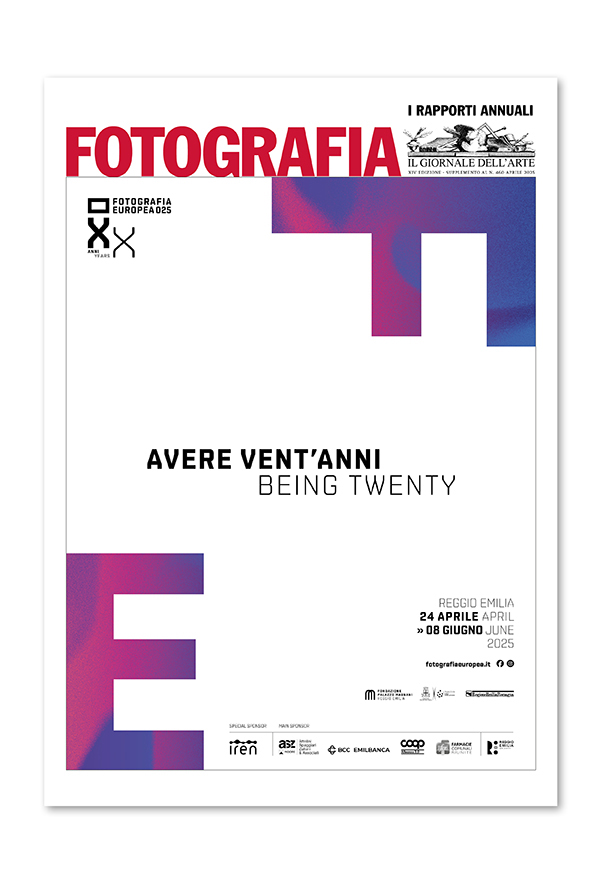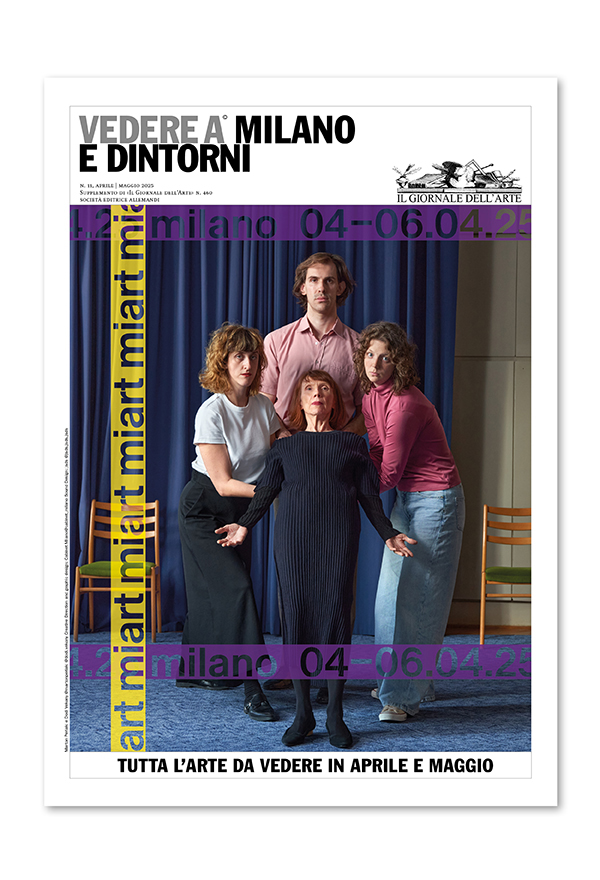Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Arabella Cifani
Leggi i suoi articoliLe Marche sono un giardino segreto, un hortus conclusus che, come sanno quelli che le hanno frequentate, bisogna conquistarsi scalando a piedi paesini inerpicati su colli, dove le automobili non arrivano. Durante il Rinascimento in quelle terre una fioritura di arte di straordinario livello si sparse lieve in pievi, chiesine, conventi, contrapponendosi, con la sua grazia, alla violenza dei tempi. Oggi sembra quasi impossibile a pensarsi, ma fra Quattro e Cinquecento le Marche furono infatti terre di turbolenze storiche non comuni, dove si consumarono tradimenti ed efferati omicidi. Basti pensare alla spaventosa fine dei Da Varano, i signori di Camerino: letteralmente scannati nel 1502 da Cesare Borgia; a Oddantonio da Montefeltro, linciato da un gruppo di congiurati nel suo palazzo di Urbino nel 1444; a Guidobaldo da Montefeltro, che dovette fuggire precipitosamente di fronte a Cesare Borgia e che vide assassinati nella strage di Senigallia i suoi migliori capitani. Su tutto quel sangue e quel tumulto scese poi progressivamente il placido governo pontificio, durato fino al 1861. La polvere di quei morti non si levò più e il silenzio ricoprì i colli.
Le Marche sono anche terra, purtroppo, di violenti terremoti susseguitisi durante i secoli e che distrussero castelli, palazzi e chiese: basta recarsi a visitare Camerino per capire quali e quanto siano stati gravi i danni dei sismi che nei secoli l’hanno quasi rovinata al suolo. Tuttavia, fu sempre tutto ricostruito, senza arrendersi alla sventura. Degli ultimi drammatici terremoti, quello del 2016 che ha anche raso al suolo Amatrice, abbiamo tutti ricordi precisi. Fra il 24 agosto e il 26 ottobre fece danni devastanti in molte città e borghi. Da subito si è cercato di salvare il patrimonio culturale di una vasta zona appenninica fra Amatrice, Norcia e Visso, con epicentri tra i Monti Sibillini e l’alta Valle del Tronto.

Lorenzo d’Alessandro, «Madonna in trono col Bambino e sant’Anna, san Rocco e san Sebastiano», seconda metà del XV secolo, Matelica (Mc), Museo Piersanti

Scultore di ambito italiano, «Crocifisso», Ancona, chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa, già chiesa del Santissimo Salvatore
A ricordare quei giorni drammatici e il grande lavoro che è stato condotto per restaurare le opere d’arte rovinate, arriva ora la mostra «Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede», a cura di Stefano Papetti e Pierluigi Moriconi, allestita nella Mole Vanvitelliana di Ancona dall’11 aprile al 15 giugno. La mostra si focalizza sulla valorizzazione e la promozione del patrimonio storico artistico proveniente da chiese e musei dei comuni colpiti dal sisma del 2016-17 e da quello del novembre 2022 nell’anconetano. Le opere presentate sono tutte restaurate da professionisti marchigiani e notevolissimo è il loro interesse storico artistico. Tra i crocifissi lignei esposti, spicca quello a rilievo su croce sagomata con cielo blu stellato realizzato per la chiesa paleocristiana dedicata al Santissimo Salvatore di Ancona. Da Ancona proviene anche la grande tela con «San Carlo Borromeo in gloria e santi» (1625-30) di Cesare Dandini.
Ci sono poi alcuni splendidi capolavori di Carlo Crivelli, Antonio Vivarini, Pietro Alamanno (indimenticabile la sua santa Lucia con i capelli biondi in riccioli serpentini) e Cola dell’Amatrice, e la magnifica pala di Lorenzo d’Alessandro, conservata al Museo Piersanti di Matelica (proveniente dalla scomparsa chiesa di San Michele Arcangelo), raffigurante la «Madonna in trono col Bambino e sant’Anna, san Rocco e san Sebastiano» (seconda metà del XV secolo). Il percorso espositivo comprende anche opere del XVII secolo di Ludovico Trasi e Giuseppe Puglia detto il Bastaro. Promossa da Anci Marche e Pio Sodalizio dei Piceni, la mostra è stata realizzata con la collaborazione delle Soprintendenze regionali e con il contributo del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, del Ministero della Cultura, della Regione Marche e dei comuni di Ascoli Piceno, Ancona e San Severino Marche.

Giuseppe Puglia, detto il Bastaro, «Madonna col Bambino e i santi Francesco e Maria Maddalena», 1632 ca, Amandola (Fm), convento dei Cappuccini