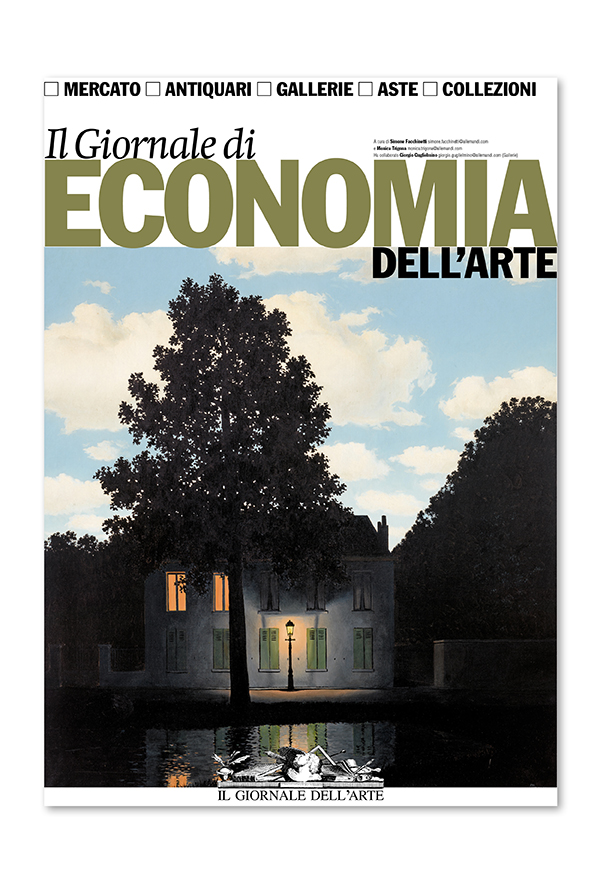Stéphane Renault
Leggi i suoi articoliFigura di spicco dell’Arte povera, Giuseppe Penone (Garessio, Cn, 1947) ripercorre in questa intervista la sua pratica e la sua carriera. Mentre nella Galleria Borghese di Roma è in corso fino al 9 luglio la mostra «Gesti universali», il Musée National d’Art Moderne-Centre Pompidou di Parigi accoglie una sua importante donazione di disegni. Abbiamo incontrato l’artista nella sua casa parigina, con vista sulla Senna.
Qual è stato il suo primo incontro con l'arte?
Parlerei piuttosto di un accumulo di immagini e situazioni. Da bambino ero interessato al disegno. Uno dei miei nonni era scultore. Alle elementari avevamo un libro, il sussidiario, con brani di letteratura accostati a riproduzioni di Michelangelo, Leonardo da Vinci ecc... Immagini molto sofisticate. Mi colpì la loro qualità, soprattutto un volto di Cristo di Leonardo che cercai di copiare. Quello è stato il mio primo incontro con la creazione, molto circoscritto, visto che a Garessio, il mio paese natale in Piemonte, non c’era un museo dove si potessero vedere opere che non fossero i dipinti barocchi della chiesa.
Figlio di agricoltori, lei è cresciuto a contatto con la natura, onnipresente nel suo lavoro. Questo suo interesse, in particolare per gli alberi, risale a quel periodo?
Sì, è così. Ho studiato ragioneria nel paese vicino al mio. Durante le vacanze scolastiche disegnavo e scolpivo. Poi mi sono iscritto all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, ma dopo un anno ho capito che lì non avrei trovato quello che stavo cercando. Era una scuola molto accademica, dove si imparavano linguaggi e tecniche per scolpire come Alberto Giacometti o nello stile di Henry Moore. Riprodurre l’opera di un altro artista però non significa esprimere la propria personalità. Dovevo trovare la mia identità e partire da ciò che conoscevo meglio. È questo che mi ha spinto a tornare a Garessio e a lavorare con gli alberi, il fiume... Creare nella natura offriva anche maggiori possibilità, mentre avere uno studio in città era costoso. Tuttavia, non volevo essere considerato un artista che lavora con il legno. Io prima di tutto stavo sviluppando un certo tipo di discorso sull’arte e le discussioni in materia si stavano tenendo a Torino. Non lontano dall’Accademia, alla Galleria Sperone, avevo scoperto gli artisti della scena americana: Donald Judd, Robert Morris... Ai tempi era la migliore galleria torinese per l’arte contemporanea.
Qual è stata la sua prima opera?
Nel mio ambito, la scultura, ho pensato di fare la cosa più semplice: stampare la forma della mia mano in negativo con la creta. Questo mi ha portato a creare, a 21 anni, nel 1968, quella che considero la mia prima opera significativa, «Continuerà a crescere tranne che in quel punto»: la mano di bronzo che tiene un tronco d’albero rappresenta il fatto che io posso influenzare la sua crescita esercitando questa forza. Ero sullo stesso piano dell’albero, ma in un’altra temporalità.
Quando e perché avete sentito l’esigenza di basare la vostra creatività su un’economia di mezzi?
Volevamo confrontarci con una realtà diversa, fare eco al cambiamento del mondo dopo la guerra. Era un periodo di sovvertimento delle convenzioni, artistiche ma anche sociali e politiche... C’era nell'aria l’idea di un'arte minimale. Ridurre al minimo le possibilità del linguaggio significava creare un nuovo alfabeto da cui partire per lavorare. Da questo approccio è nato un concetto formale. La semplicità dei mezzi corrispondeva anche a un desiderio di precisione: riducendo i mezzi espressivi si è più sintetici e ciò che si vuole dire diventa più chiaro.
Germano Celant, che nel 1967 teorizzò l’Arte povera, di cui lei è uno dei capofila, scrisse su «Flash Art»: «L’importante era corrodere incidere e frantumare, tentare una decomposizione di un regime culturale imposto». Questo impegno politico ed ecologico, questo rifiuto della società dei consumi degli anni Sessanta era una parte imprescindibile della sua pratica artistica?
Gli artisti del gruppo avevano in comune questo tipo di pensiero. C’erano regole non scritte che definivano come concepivamo l’oggetto artistico. Lavorare con elementi insoliti in questo contesto significava cambiare il modo di vedere le cose. Si trattava di rinnovare lo sguardo, di affermare una visione originale della realtà, non solo di contestarla. Volevamo proporre qualcosa di positivo, un’utopia. All’epoca c’era una rete, luoghi in cui le persone potevano incontrarsi per scambiarsi idee. Il mondo dell’arte era un villaggio nel villaggio globale. Non c’era organizzazione, era sufficiente discutere con un artista americano qualche minuto per capire che condividevamo lo stesso punto di vista. Avevo 23 anni la prima volta che andai a New York, nel 1970. Una sera, nella sua galleria, Ileana Sonnabend mi chiese se volevo incontrare Robert Rauschenberg e andammo nel suo studio, dove c'era anche Cy Twombly. Gli scambi tra artisti erano molto naturali, ad esempio in un bar. Era un tipo di comunicazione diretta, che è durata fino agli anni Settanta.
Qual è stato il suo rapporto con gli altri artisti dell’Arte povera?
A Torino vedevo soprattutto Marisa e Mario Merz, Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio, Pier Paolo Calzolari, ma incontravo con regolarità anche Emilio Prini, che viveva a Genova. Eravamo amici e non c’era molta competizione legata al mercato. In termini di idee però... Se uno usava una tovaglia e un altro decideva di fare lo stesso, si creava un problema! Ricordo un conflitto tra Pier Paolo Calzolari e Jannis Kounellis. Il primo aveva progettato un’opera con un trenino, oggetto ripreso dal secondo, ma, secondo Calzolari, il riferimento era a Giorgio de Chirico...
Ricordo che Kounellis e io eravamo stati invitati alla Biennale di Tokyo e, al ritorno, eravamo rimasti bloccati a Beirut per tre giorni. Era prima della guerra, ma si sentiva la tensione nel Paese. Dal Giappone avevo portato una macchina fotografica, visitammo la città, i resti romani, bevemmo caffè turco... Kounellis era greco. Non bisogna dimenticare che l’Arte povera non riuniva solo artisti italiani, come accadeva all’inizio. Per scrivere il suo libro Arte povera, che è diventato un punto di riferimento, Germano Celant ha chiamato artisti di varie nazionalità.
Lei ha detto di «cercare di lavorare con la materia, non contro di essa». È inevitabile non pensare alle sculture in cui lei fa affiorare i rami dell’albero dal cuore del tronco. Perché è importante per lei?
Ogni materiale ha delle possibilità espressive. Imporre una forma a un materiale solitamente è un errore. Una scultura concepita per essere in marmo probabilmente in bronzo non funzionerà. E viceversa. A scuola avevo un insegnante di scultura che lavorava soprattutto con l’argilla, attraverso gesti molto delicati. E poi fondeva i suoi pezzi. Ricordo una delle sue sculture in bronzo che aveva rifatto realizzare in marmo. Era orribile! Tutta la freschezza del gesto era sparita. Sono convinto che bisogna seguire il materiale. Non capisco gli artisti che fanno gli stessi pezzi in resina, in metallo... È in gioco anche la posizione dell’uomo rispetto alla natura. Okakura Kakuzô, un giapponese che dirigeva la sezione orientale del Museum of Fine Arts di Boston, ha scritto un testo molto bello intitolato Il libro del tè. Parla di uno strumento regalato a un re ricavato da un ramo di un albero sacro, che produce una musica straordinaria solo quando il brano suonato racconta la storia dell’albero, il ciclo delle stagioni... Seguire la materia ci dà immagini sufficienti per capire la realtà. Non c'è bisogno di imporre su di essa ciò che non sarebbe giusto. In un’altra occasione, sono stato da un fabbro che, vedendo uno dei suoi giovani dipendenti arrabbiarsi per un lavoro, mi ha detto: non capisce che bisogna seguire il ferro. È la stessa storia. Conoscendo e rispettando il materiale, si ottengono risultati notevoli. C’è un fondo di verità, ha senso.
La sua donazione di 328 disegni al Centre Pompidou ha dato vita alla mostra «Giuseppe Penone. Disegni», da poco conclusasi. Che cosa rappresenta il disegno nella sua pratica?
È una forma di espressione, di annotazione, un elemento di studio alla base del mio lavoro. La selezione presentata al Centre Pompidou riflette questa produzione dagli anni Sessanta a oggi. Non faccio mai disegni fini a sé stessi, per una ricerca estetica, ma con l'obiettivo costante di evocare la forma. Sono un passo necessario, un lavoro di ricerca preciso per arrivare a questa sintesi che è la scultura. Spesso preparatorio, il disegno a volte prolunga anche il lavoro scultoreo. La libertà che offre si esaurisce una volta terminata la scultura. Fino agli anni '90 non avevo mai esposto questi disegni. Negli anni ’60 e in quelli successivi, era fondamentale presentare solo l'opera, senza compromessi. Il concetto doveva essere radicale, nulla doveva essere spiegato. All'epoca aveva senso. Grazie alla donazione al Beaubourg, questi disegni sono conservati nel loro insieme invece di essere dispersi sul mercato.
----
Sempre in Francia, nel 2022 è stato invitato a esporre presso il Convento di Sainte-Marie de La Tourette a Eveux-sur-Arbresle, patrimonio mondiale dell’Unesco. Per quel progetto si è ispirato all’ambiente naturale, ma anche all’architettura di Le Corbusier, in particolare in una serie di disegni realizzati direttamente sulla superficie di cemento. Com’è stato lavorare in quel luogo?
Credo che tutte le volte che si allestisce una mostra, a maggior ragione in uno spazio così connotato, si debba cercare di non tradire lo spirito del luogo. Altrimenti quanto si è prodotto non s’integrerà mai nel contesto. Anche nell’ambito di una mostra temporanea le opere devono essere concepite e presentate come se dovessero rimanere lì per sempre. La Tourette è uno spazio religioso, un luogo di meditazione e di preghiera, che si sia credenti o meno. Su invito di Fratel Marc, mi è sembrato di dover scegliere opere legate al luogo, contenenti riferimenti all’iconografia cristiana. A seconda che un’opera sia installata in un museo o in una chiesa, la sua percezione e il suo significato cambiano completamente. Essendo già stato invitato due volte a esporre a La Tourette, anche se poi non se n’era fatto nulla, avevo visitato il sito. Il tempo che vi ho trascorso mi ha permesso di capire che l’intero edificio è come una foresta, composta da una fila di tronchi d'albero sormontati da rami e fronde che si stagliano all’altezza delle celle dei frati domenicani. L’edificio è sospeso su un pendio e in un punto ci sono dei ciottoli incastrati nel muro che ricordano delle foglie. Le Corbusier non l’ha mai detto, ma forse inconsciamente si è ispirato all’idea di una foresta in cui vivono i frati, un po’ come il Barone rampante di Italo Calvino. L’unica parte dell’edificio a diretto contatto con il suolo è la chiesa, nella cripta.
Partendo da queste osservazioni, oltre all’installazione di sculture, ho deciso di fare dei frottage sulle casseforme che avevano lasciato tracce delle nervature del legno nel cemento. L’idea era di trovare l'albero dentro il legno, come se ogni impronta del legno fosse un albero. Le Corbusier aveva messo a punto una tabella di colori a cui faceva riferimento per i suoi edifici. Ho potuto recuperare questi dipinti e lavorare su tele sottilissime, posate su quelle superfici.
Con la curatela di Francesco Stocchi, lei attualmente espone delle sue opere alla Galleria Borghese di Roma. Come si è preparato per questa mostra, ancora una volta ospitata in uno spazio molto speciale?
La Galleria Borghese non è stata concepita per esporre arte contemporanea. Lo scopo della collezione Borghese era di riunire meraviglie, fossero esse opere d’arte o piante rare dei giardini. C’era anche un’uccelliera con volatili esotici. L’idea era quella di stupire. Lavorare qui non è facile, ma è molto stimolante. Se ci si accontenta di un semplice confronto formale con il proprio lavoro, secondo me non si coglie il punto. Così ho cercato nel mio lavoro elementi che potessero dialogare con quelli presenti nella Galleria. All’ingresso è stato collocato un gruppo di alberi, una sorta di boschetto, quale riferimento alla natura ma anche all’architettura. Ho poi scelto di esporre solo in tre sale. Per il gruppo scultoreo di «Enea, Anchise e Ascanio» Bernini si era concentrato sulla pelle, un aspetto, questo, che entra in risonanza con alcune mie opere sul tema del tatto. Nella Sala degli Imperatori, che ospita il suo «Ratto di Proserpina», ho allestito pezzi che esprimono l’idea del respiro, dell’impronta del corpo, in particolare «Respirare l’ombra», costituita da foglie. Infine, nella sala dell’«Apollo e Dafne», ho appeso alla parete due opere composte da foglie di alloro. Nei giardini, il dialogo continua tra piante e sculture in bronzo. Bisognava trovare il modo migliore per integrarsi nell’intimità di un simile luogo. Esporre accanto a Bernini è un’esperienza eccezionale, che mette a confronto due approcci alla scultura.
Ha insegnato all'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris dal 1997 al 2012. Il Centre Pompidou ha organizzato una retrospettiva del suo lavoro nel 2004, il Castello di Versailles ha ospitato le sue sculture nel 2013 e lei è ora membro dell’Académie des Beaux-Arts di Parigi. Questa intervista si svolge nella sua casa parigina, affacciata sulla Senna e sull’Ile Saint-Louis. Si sente un po’ francese d’adozione?
Le sorelle di mio padre si erano trasferite in Francia e ho imparato a parlare il francese con i miei cugini che venivano a trovarci in Italia. Nel 1969, mentre partecipavo alla mostra «Prospect» alla Kunsthalle di Düsseldorf, ho pensato per la prima volta di andare a Parigi, per essere presente all’inaugurazione di una mostra del mio amico Giovanni Anselmo da Ileana Sonnabend. La mattina, mentre stavo per partire, il suo segretario, Antonio, mi dice di dover rinunciare al viaggio perché ha dimenticato la borsa nel ristorante dove avevamo cenato la sera prima. Così vado alla stazione da solo e con i pochi soldi che mi erano rimasti compro un biglietto. Una volta sul treno, mi sono reso conto di non avere nemmeno l’indirizzo della galleria... All’arrivo ho preso un taxi, senza dire all’autista che non sapevo dove andare, dicendo semplicemente: «In centro!». A un certo punto ho visto la cupola dell’Académie française e la parola «Mazarine». Allora mi sono ricordato che si trattava di rue Mazarine. Il taxi svolta e la galleria era a 100 metri, così sono sceso e ho chiesto in prestito dei soldi per pagarlo. Ho capito che Parigi non mi era ostile.
Dal suo lavoro promana una sottile poesia. Lei legge poesia? Vi sono autori che l’hanno colpita in modo particolare?
La poesia richiede la stessa necessità di sintesi dell’arte plastica: la concentrazione, il modo di immaginare sono paragonabili. L’opera, come le parole, deve riuscire a evocare il mondo. M’interessavano molto i romantici tedeschi: Goethe, Hölderlin. Ma anche Leopardi. La letteratura e la musica implicano un tempo di lettura, di ascolto... E io di tempo non ne ho molto. Con la poesia, basta leggere pochi minuti per avere materia di riflessione per tre ore. Ciò detto, una sola pagina di Fëdor Dostoevskij contiene una tale ricchezza espressiva da essere altrettanto autosufficiente.
Che rapporto ha con la musica?
Anche se sono sordo da un orecchio, quando lavoro ascolto musica. Ma non saprei dire con certezza se ho ascoltato Chopin o altro. Ho una memoria prevalentemente visiva.
Che consiglio darebbe a un giovane artista?
Di seguire le proprie convinzioni, capire la realtà e lavorare sulla propria identità. Deve esserci forza nell’espressione, e a questo si perviene con la pratica. Il valore di un’opera si nutre del bisogno che l’artista sente per essa, è esistenziale. A seconda del momento storico cambia il modo in cui un'opera viene vista, ma se risponde a questo criterio il suo valore permane. Se si crea solo per piacere, non dura. Mentre il mercato dell'arte fa e disfa il valore delle opere, per un artista contano solo la sincerità e la necessità di creare. Altrimenti è solo decorazione.

Una veduta della mostra «Giuseppe Penone. Gesti universali», Rome, Galleria Borghese © Galleria Borghese. Foto S. Pellion

Una veduta della mostra «Giuseppe Penone à La Tourette» (2022), Éveux, Convento di Santa Maria de La Tourette © Archivio Penone. Foto D.R

«Senza titolo» (1970) di Giuseppe Penone © Archivio Penone
Altri articoli dell'autore
Nell’ambito del Festival d’Automne di Parigi, il Centre Pompidou dedica una retrospettiva all’artista e regista thailandese, vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 2010
Il volubile e spesso caustico critico d’arte e curatore, nato a Firenze nel 1955, parla della sua carriera, dei suoi amici artisti e del mondo dell’arte contemporanea
L’artista francese si è suicidato subito dopo la scomparsa improvvisa della moglie Annie. Aveva 88 anni
Da Gagosian e a Tokyo, due mostre sul poliedrico artista americano che spazia dalla pittura all’urbanistica e ora dialoga con la cultura giapponese