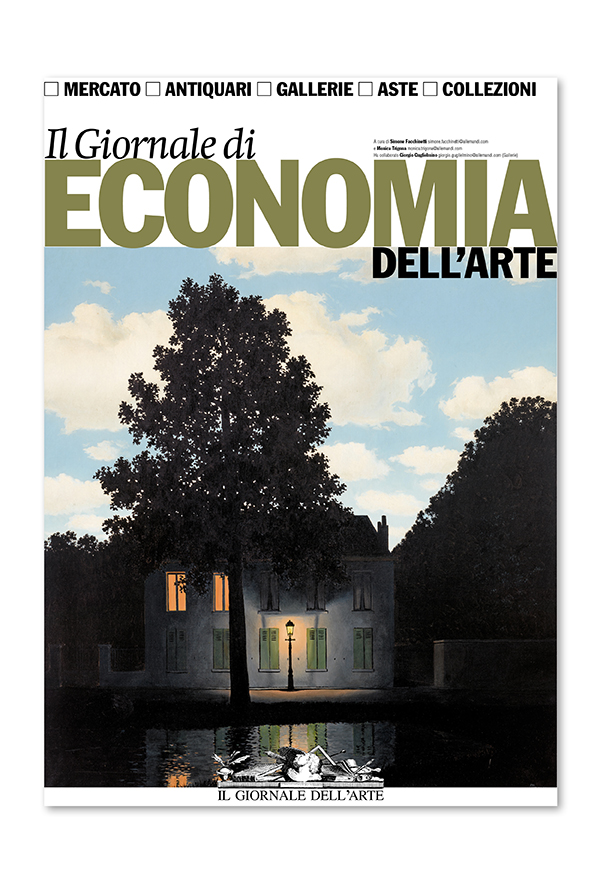Dal 28 settembre al 27 ottobre Triennale Milano presenta la mostra di Gianni Politi (Roma, 1986) «Le stelle per te, dentro»: un’inedita installazione concepita appositamente per lo spazio, in cui nuovi lavori dialogano con serie precedenti. Al centro della scena la grande tela intitolata «I giorni dei pentimenti» (2024), in cui è raffigurato il volto del padre dell’artista ispirato al dipinto «Studio per un uomo con la barba» (1770) di Gaetano Gandolfi, che da oltre un decennio l’ha eletto a soggetto d’elezione della propria indagine pittorica. Il progetto espositivo a cura di Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e public program di Triennale, si inscrive in un contesto di più ampio respiro che vede l’istituzione impegnata, già da alcuni anni, a valorizzare la scena emergente e traccia una linea di continuità con la mappatura della pittura italiana contemporanea celebrata lo scorso anno con la grande ricognizione «Pittura italiana oggi», di cui Politi è stato uno dei protagonisti.
Vorrei cominciare dal titolo della mostra per esplorare un aspetto, quello autobiografico, che è specifico della sua pratica. La sua produzione si sviluppa sempre da un’esperienza intima e questa volta muove dalle stelle dentro di lei. Ci racconta in che modo?
Immagino il mio lavoro come qualcosa che nasce nello studio, da pensieri interiori, da ricerche estremamente personali. La vita dell’artista è, in fondo, una vita solitaria, a tu per tu con le proprie ossessioni e le proprie manie. Le cose che interessano un artista sono molto individuali, ma poi diventano pubbliche nel momento in cui il lavoro viene mostrato. In quest’occasione ho cercato di far capire, attraverso il titolo, l’uso del concetto di notte, di stelle, di viaggi notturni. Ho ragionato come se le opere fossero queste stelle, le stelle dentro di me che, quando vengono mostrate, diventano le stelle per te che le guardi. È un titolo sentimentale, utilizzato per presentare lavori nuovi ma che fanno riferimento a ricerche precedenti, che porto avanti oramai da più di dieci anni. Il modo in cui adopero le parole e la scrittura per titolare dipinti o mostre è non solo un modo per aprire informazioni segrete ma anche per indagare la questione del tempo. In un futuro lontano, se il mio lavoro avrà avuto un senso, un valore per i contemporanei e si sarà salvato dall’apocalisse culturale, ci sarà qualcuno che avrà trasportato parola per parola tutte queste cose che ho pensato, seduto nel mio studio? Chissà!
Il suo lavoro viaggia su due binari paralleli, quello dell’astrazione e quello della figurazione, ammesso che possa definirsi figurativo un pittore che da oltre 10 anni prova ad afferrare, senza riuscirvi, lo stesso ritratto. Che significato sottende, a livello più profondo, questo incessante, ossessivo inseguimento della forma che rimane però sempre instabile e indeterminabile?
Questa ricerca sul ritratto, che in realtà non è condotta in maniera differente dalla ricerca sull’astrazione, nasce per cercare di rispondere a una domanda fondamentale: che cosa è giusto dipingere per me? E che cosa è giusto dipingere per un pittore, per un artista che vuole essere un pittore? Ritornare sul quadro, insistere sull’immagine, è proprio voler sottolineare che il lavoro non è tanto il risultato estetico, ma bensì il processo, il tempo dedicato, il fallimento, il recupero di un certo materiale. Quindi, sia la serie figurativa, che è sempre lo stesso ritratto da più di 10 anni, sia quella astratta, che è cambiata perché sono cambiati i materiali, sono per me due facce della stessa medaglia. La medaglia è questa grande domanda sul significato che ha ancora dipingere, su come si può definire un dipinto finito, se ha senso finire effettivamente un dipinto e donare al mondo un’immagine stabile. Tutti questi sono gli interrogativi che mi hanno sempre mosso e che continuano a muovermi, nonostante alla Triennale sia esposto l’ultimo dipinto di questa lunga serie. Ma «I giorni dei pentimenti» non è per me il dipinto finale, è soltanto l’ultimo. È un’opera in cui ho dovuto mettere molto e per molto intendo anche conoscenza, quella accumulata dipingendo per tutto questo tempo lo stesso soggetto. E soprattutto, nonostante la sua monumentalità, ontologicamente ha per me lo stesso valore dei dipinti di piccolo formato, che ho mostrato in altre occasioni.
Diceva bene Artaud che: «L’unica cosa diabolica, oggi, è starsene a lavorare di fino su forme, invece di essere come dei condannati, che continuano a fare segni sui loro roghi».
Mentre quest’estate, dello stesso autore, leggevo Eliogabalo o l’anarchico incoronato rimanevo affascinato dal suo modo di costruire, decostruendoli, il tempo e la storia. Potrei dire che questa indefinitezza della forma è la cifra mia e di tanti artisti intorno a me che per biografia, per contesto, per contingenza o studi, non si trovano al centro di argomentazioni costitutive della nostra contemporaneità. In questi anni di ricerca credo che la complessità estetica che ho raggiunto nei miei lavori possa dirsi paritetica alla loro complessità concettuale. Molto spesso l’estrema articolazione dei dipinti, anche il loro essere a volte vertiginosamente ben fatti, piacevoli o belli a giudizio di alcuni, ha fatto un po’ dimenticare il presupposto concettuale da cui vengono, cioè questo tentativo continuo di trasformare in un dipinto il tempo che trascorro in studio, provando a diventare un pittore.
La tela principale, che si erge come inscritta in un’abside, accompagnata da panche che sembrano un invito alla sosta, rimanda a un’idea di contemplazione e sacralità. Cos’è il sacro per lei?
Il sacro per me è lo sforzo. Lo sforzo è sacro, perché lo è il lavoro in qualche modo. Per l’allestimento ho immaginato di far entrare lo spettatore non tanto nell’impluvium quanto in un luogo mentale. Deve varcare la soglia facendo un piccolo giro, una sorta di inciampo, per accedere a un ambiente dentro il quale le opere sono le opere, ma il luogo è l’opera e il lavoro è il luogo. E il lavoro non è un’opera sola ma sono tutte le opere.
Riprendo il termine «soglia» nella sua accezione di passaggio tra due mondi, perché completano l’esposizione alcune sculture di rane, anfibi che incarnano l’idea della trasformazione.
Sono affascinato dai simboli, dal loro valore, e quindi in ogni mio progetto faccio riferimento a un animale, che può essere nel lavoro anche solo spiritualmente e non necessariamente come sostanza fisica. Per esempio, in un mio scritto riflettevo sul fatto che il pennello è fatto con i peli della bestia, ma quale sia la bestia non è dato saperlo. In una mostra ho invece evocato l’immagine del serpente, perché secondo me è dentro la sua pancia che vive il pittore. In questa occasione ho voluto utilizzare le rane. Sono lì, ci guardano e ci aiutano a guardare. E con il loro immaginato canto ci permettano di entrare meglio nella notte.

«1929» (2023) di Gianni Politi. Foto: Giorgio Benni. Cortesia della Galleria Lorcan O’Neill