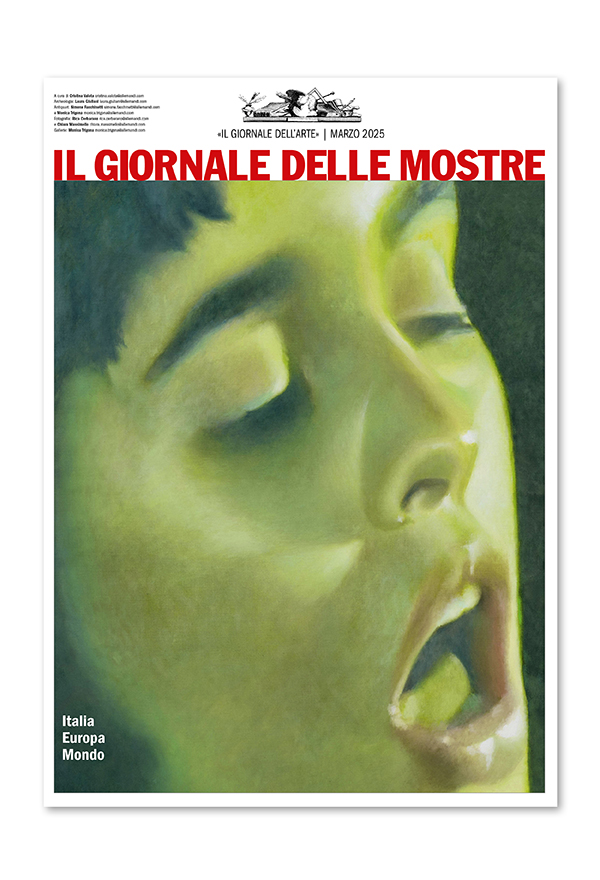Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Elena Dellapiana
Leggi i suoi articoliDopo la ricognizione ampliata sugli spazi permanenti allestiti da Donald Judd (1928-94) a New York e in Texas (Donald Judd Spaces, 2023), la collaborazione tra l’archivio dell’artista e la casa editrice Mack offre un affondo sui mobili progettati e poi messi in produzione tra gli anni Settanta e la morte di uno dei giganti della Minimal Art. Concepito come un catalogo ragionato, completo di disegni tecnici e splendide fotografie, il volume Donald Judd Furniture (448 pp., ill. col. e b/n, Judd Foundation/ Mack, Londra 2024, € 70) dialoga con l’apposita sezione del sito della Fondazione, dalla quale si può accedere anche allo shop per acquisire, certificata e numerata secondo il sistema dei multipli d’autore, una porzione della sua arte (Donald Judd, volutamente, non ha mai protetto i suoi disegni con brevetti e questo ha portato a numerose contraffazioni a prezzi stracciati, come i 300 euro richiesti su Etsy per la sua iconica «Chair 84»; sul web, le versioni originali e autentiche partono da 20mila euro, ma nel 2022 un suo tavolo ha raggiunto, in un’asta Christie’s New York, i 350mila dollari, Ndr).
Sul rapporto tra arte, design e architettura interviene lo stesso artista nei testi ad accompagnamento: dallo scritto It’s hard to find a good lamp (1993), prodotto in occasione della prima retrospettiva sui suoi mobili al Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, al breve intervento del 1989 in cui Judd mette in relazione il proprio lavoro nei campi dell’arte visiva, dell’architettura e del design, a un’intervista del 1992 in occasione del suo progetto per la fontana in Steinberggasse a Winterthur. Se da una parte i suoi oggetti d’uso non sono che una logica conseguenza della sua volontà di sfuggire a qualsiasi appartenenza ai campi della pittura e della scultura (e dunque perché non design?), dall’altra il tema «arte-design» solleva più di un interrogativo, al quale possibili risposte sono venute tanto dagli artisti quanto dai designer e sono oggi collocate in uno spazio ibrido quanto fortunato commercialmente definito di volta in volta «art-design», «collectible design» e così via, con gallerie e aste dedicate, insegnamenti nelle scuole di design e nelle accademie e una vivacissima pubblicistica.

Tavolo basso esposto al quarto piano della Judd Foundation a New York. Foto: Matthew Millman © Judd Foundation. Cortesia della Judd Foundation e Mack
Si tratta comunque di un tema presente nel dibattito fin dagli anni Sessanta e in particolare con la mostra-show «Antagonisme 2: l’objet», ideata e curata da François Mathey nel 1962 presso il CCI (che sarebbe diventato il Centre Pompidou), dove un centinaio di artisti erano stati chiamati a misurarsi con gli oggetti d’uso e quotidiani e con lo spinoso tema della decorazione. Se Judd ammette iniziali fallimenti dovuti «all’incapacità dell’arte di diventare arredamento», altri, come Ron Arad, non hanno avuto dubbi già alla fine degli anni Ottanta, ad esempio con l’installazione-poltrona «Big Easy» (1988), che dall’acciaio saldato (una scultura «sedibile») ha portato alla produzione in serie (per Moroso), o alla libreria «Bookworm» (Kartell dal 1994), un pezzo pienamente calato nell’industrial design a prezzi relativamente accessibili. Di tutt’altro tenore la strada inversa, quella dei designer che espongono nelle gallerie d’arte oggetti impegnativi da tutti i punti di vista, che ricchi clienti desiderano per caratterizzare con un intervento artistico le proprie case e luoghi di rappresentanza. Le sedute e i sistemi di illuminazione di Daniel Libeskind, Zaha Hadid o Rem Koolhaas, tra gli altri, rispondono all’esigenza di circondarsi di oggetti «speciali», dotati di un’aura anche se prodotti in serie: in sintesi, il nocciolo dell’idea stessa di molto design contemporaneo, una volta archiviato il dogma «la forma segue la funzione».
Le serie di mobili di Judd sembrano andare esattamente nella direzione opposta: sedie, basi per letti e divani, scaffali e tavoli dalle forme elementari ed esito di famiglie e variazioni, in cui il legname in poche pezzature assemblato o montato su esili telai metallici rimanda alla produzione anonima nordamericana, a bassa intensità artigianale e che sfrutta la meccanizzazione per i semilavorati (legname per edilizia, balloon-frame ecc.) oppure ai pensieri emersi in seno alla scuola di Ulm (1947-68) e agli austeri prodotti che ne scaturiscono. Lontani perché firmati da un artista ma vicini per il carattere Diy (Do It Yourself), i mobili di Judd fotografano tutte le contraddizioni (concetto, produzione, significato, fortuna) del design contemporaneo che guarda alla lunga durata o al successo immediato. E le sue affermazioni («che razza di società è questa, se non si può nemmeno comprare una sedia?»), alle quali verrebbe da rispondere consigliando un giro all’Ikea, fanno venire il sospetto che dietro il suo luddismo «in salsa chomskiana» si celi una volontà di disorientare chi sia alla ricerca di un senso e di riconoscervi una cornice, ma, dopotutto, come lo stesso Judd ricorda più volte, «una buona sedia è una buona sedia».

Tavolo di architettura in compensato «Slip Together» presso Architecture Office, Marfa, Texas. Foto: Matthew Millman © Judd Foundation. Cortesia della Judd Foundation e Mack