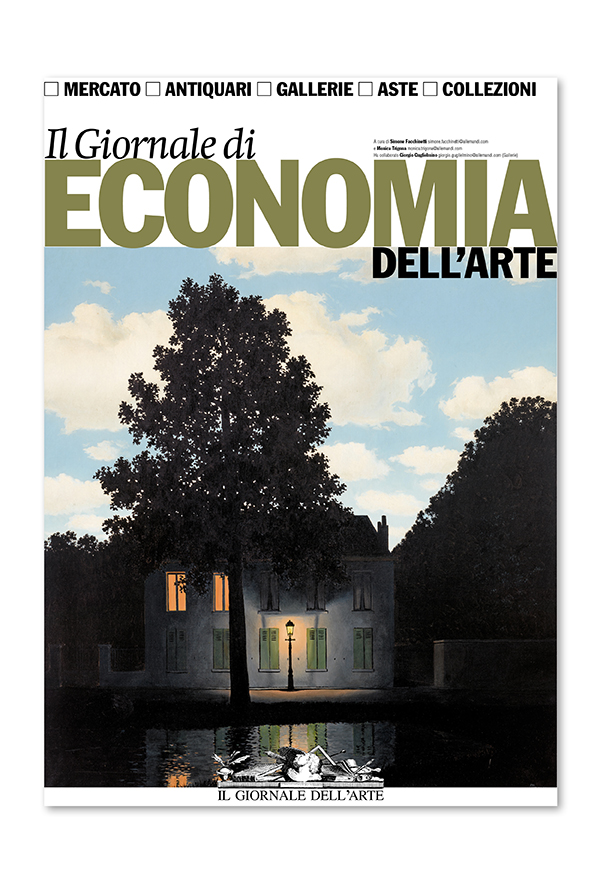Alessandra Mammì
Leggi i suoi articoliDiego Perrone è nato nel 1970. Dunque nel 1988, quando si diploma al Liceo artistico della sua città (Asti) e si trasferisce a Milano, il muro di Berlino non era ancora caduto, internet in Italia era appena un esperimento e bisognava aspettare un paio d’anni e i mondiali di calcio per veder messo in vendita il primo cellulare. Diego aveva intrapreso studi artistici perché la maestra delle elementari aveva detto alla mamma che il bambino «era portato per il disegno», ma dopo il diploma aveva deciso di raggiungere l’Accademia di Brera forse proprio per smettere di disegnare.
A Brera si era iscritto ai corsi di Luciano Fabro che stimava molto come artista ma come insegnante, ci racconta, risultò troppo criptico per lui. Fabro teneva le lezioni in un’aula magna piena di studenti che arrivavano da ogni parte per ascoltarlo, ma vietava drasticamente di usare registrazioni. Diego, reduce da studi in provincia, aveva difficoltà a seguirlo. Inoltre soffriva di timidezze che gli rendevano ostico avvicinarlo e chiedere un colloquio, quindi finì per sentirsi un disadattato. Così in quello strano limbo dove ancora non si parlava di digitale ma inevitabilmente tramontava il ’900 con tutte le sue avanguardie e le sue ideologie, Diego Perrone, come altri aspiranti artisti della sua età, vagava alla ricerca di una strada e di un maestro.
Fu all’Accademia Albertina di Torino, dove si era rifugiato dopo le frustrazioni di Brera, che Mino Ceretti, insegnante vecchio stile legato all’esistenzialismo pittorico, riuscì a capire le sue aspirazioni e a indirizzarlo a Bologna da un docente che avrebbe potuto essergli congeniale: Alberto Garutti, artista e maestro che avrebbe lasciato il segno su una generazione intera. È da qui che parte la conversazione che segue. Un ritratto dell’artista fin da giovane nato sull’onda di due tappe importanti che hanno visto il lavoro di Perrone tra i protagonisti della scorsa stagione: la potente mostra al Macro di Roma («Pendio piovoso frusta la lingua», 29 settembre 2022-19 marzo 2023) e la pubblicazione della bella e densa monografia Diego Perrone Works, curata da Luca Cerizza e pubblicata da Mousse.
Non solo per lei, Diego Perrone, ma anche per Giuseppe Gabellone, Sarah Ciracì, Simone Berti, Stefania Galegati e per molti altri artisti della sua generazione ricorre il nome di uno stesso maestro: Alberto Garutti. Vi chiamarono addirittura «garuttini», come fosse un movimento o una nuova scuola. Eppure ognuno di voi ha percorso strade e ricerche diverse, ognuno ha una sua distinta e riconoscibile personalità e per di più piuttosto lontana dal lavoro del maestro. Quali sono state, allora, le basi di questo insegnamento?
Più che di insegnamento parlerei di un metodo. Riusciva a caricare gli studenti, ad accompagnarli per mano, a sminuire l’aura dell’arte dei padri poveri o concettuali, che in fondo ci intimidiva. Io ero affascinato dall’arte ma non ero affatto sicuro di esserne all’altezza. Lui abbassava la temperatura, faceva scendere l’arte dal piedistallo, ci portava nel mondo reale e materiale di un mestiere, ma soprattutto ci metteva al suo stesso livello. Vorrei poter dire, senza essere frainteso, che finalmente ci si sentiva un professionista, padrone dei propri mezzi. La sua lezione consisteva nel chiedere di portare un’opera in aula e discuterla. La cosa bella è che a volte lo faceva anche con i suoi stessi lavori. Eravamo allievi, ma anche colleghi. È una cosa che dà energia e fiducia. Vedo il «metodo Garutti» come una miccia che ha fatto esplodere un linguaggio comune a tutti noi.
Che cosa c’era in comune fra voi allievi?
Abbiamo condiviso un periodo molto particolare e un appartamento particolare: a Milano, in via Fiuggi. Eravamo in nove, tutti allievi di Garutti, accampati in un seminterrato. Il mio regno era una zona letto ricavata da un sottoscala grazie a un muro che avevo costruito con le mie mani. Ma era un «appartamento che non dorme mai» dove a qualsiasi ora, anche alle quattro del mattino, trovavi qualcuno sveglio a fare arte o a discuterne con gli altri artisti o con qualche critico e curatore di passaggio. Ne passavano tanti, da Maurizio Cattelan con Massimiliano Gioni a Luca Cerizza, Roberto Pinto, Giacinto di Pietrantonio. E anche tanti galleristi o artisti internazionali. Quella casa aveva qualcosa di magnetico, funzionava da catalizzatore. E sebbene fossimo chiusi in un circolo in fondo ristretto, si respirava nell’aria un’energia fuori dal comune e la consapevolezza di vivere un momento speciale. Erano gli anni in cui abbiamo visto la nascita di internet, lavorato con il digitale ai suoi inizi quando non si sapeva ancora bene che cosa fare di un computer e per scaricare un Mp3 ci si metteva una giornata. Ma in tutto questo si avvertiva una grande eccitazione e la possibilità di creare un immaginario diverso.
Diverso da che cosa esattamente?
Diverso da quello che c’era prima e da quello che ci sarebbe stato dopo. Prendiamo, ad esempio, il mio video del 2005 che ha per titolo «Vicino a Torino muore un cane vecchio». All’inizio doveva essere la narrazione della morte di un grande artista, poi è diventata la descrizione dell’agonia di un cane totalmente inventata. Lo avevo realizzato con un software veramente arcaico che nessuno ora usa più. Mi facevo aiutare da un nerd autodidatta che era bravissimo ad aggirare ogni problema ma era come modellare, far qualcosa di manuale, lavorare un software con martello e scalpello anche perché la nostra testa era ancora quella dell’artigiano. Più tardi ho realizzato un’animazione con studi professionali che garantiscono un prodotto perfetto ma allo stesso tempo impersonale. In quel video del cane, invece, riconosco un valore «rugoso» che lo rende quasi pittorico, una materialità che lo fortifica. Riprendere un cane che muore con un’immagine digitale è un fatto di cronaca. Dipingere un cane che muore in punta di pennello è qualcosa di eterno che non ha a che fare con l’immediatezza della morte. Quel video si pone nel mezzo: è la morte in tempo reale di quel cane ma anche la morte in sé, la morte di tutti i cani, o di tutti gli artisti.
Sembra una metafora della sua stessa formazione...
Nella mia formazione c’è di tutto: il metodo Garutti e le lezioni di Francesca Alfano Miglietti, che era interamente proiettata nel mondo della realtà virtuale e profetizzava a noi studenti la totale scomparsa della materialità. Ma mentre lei ci annunciava il futuro mondo rarefatto, io riempivo una libreria di dischi dei Joy Division, Cure o Steve Reich. È ancora lì. Un blocco volume pieno zeppo di cd che occupa uno spazio ed è la prova fisica della mia formazione a cavallo fra due mondi. Perché ritengo sia pericoloso inebriarsi di una scienza che ti proietta continuamente e talmente in avanti che alla fine non c’è più stabilità. Io credo che tutti gli artisti debbano fare i conti con la realtà e zavorrare i propri piedi, perché se perdi il contatto con la forza di gravità rischi un conflitto insano con te stesso e con il tuo lavoro.
Il suo maestro Garutti sosteneva appunto che «l’artista è un curatore della realtà». È anche per questo che oltre ai titoli spesso lei accompagna le opere con brevi testi descrittivi?
Io scrivo cose brevi. Cose che vivo in prima persona e che non si vedono nell’opera. Non è solo uno strumento utile dal punto di visto descrittivo, ma direi più un modo di aprire la porta della sala, un’introduzione al mio lavoro e al mio pensiero. Per «I pensatori di buchi» del 2002, ad esempio, avevo scritto che «dovevo rappresentare invece che fare, creando un luogo e ragionando in termini di immagini... così per un anno circa ho scavato sette buchi di profondità diverse tra i sette e cinque metri... poi ho inventato un nuovo soggetto, creatura immaginaria che vive in uno stato di simbiosi con i buchi e subisce costantemente il peso della loro astrazione ecc...». Al Macro i miei testi sono stati usati per un’audioguida. Mi ha stupito ascoltarli: quasi non li riconoscevo, tanto che ho pensato: «Beh, dovrei farne un libro!».
Di nuovo un oggetto concreto.
Dal momento che appartengo a una generazione confusa a cavallo fra due mondi, come abbiamo detto finora, posso permettermi di amare tanto la materia che la sublimazione e l’immaterialità. Sono affascinato dai tre minuti di slow motion del mitico salto all’indietro di un atleta filmato da Bruno Munari nello spot di Tissot come visione di eterno galleggiamento; vengo catturato dalla luce della cattedrale di Monet che vorrei respirare e persino starnutire; osservo le cose in sospensione e cerco l’immagine a cui regalare quello stato gassoso che diventa un potenziale emotivo come una vittoria sulla gravità. Se ho osservato e studiato la scultura di Adolfo Wildt è perché mi interessava la superficie liscia e levigata che diventava forma, ma volevo desacralizzarla, usarla come mezzo, non come icona (cfr. «Vittoria (Adolfo Wildt)» realizzata per «Il Palazzo Enciclopedico», Biennale di Venezia 2013, Ndr). Lo stesso vale per le mie ultime sculture, che nascono in un blocco di vetro, in cui quello che mi interessa non è il modellato ma la luce che attraversa la materia, la trasparenza che le rende antimonumentali, la nitidezza che diventa punto di arrivo. Guardare dentro le sculture, cercare la profondità della materia per scoprire che non c’è nulla di nascosto, la loro profondità è nuda, vestita solo di macchie di colore.
Ma essere nati nel secolo breve e lavorare in piena rivoluzione digitale lo considera un peso o un’opportunità?
Mi sento fortunato nell’appartenere a una generazione che non è costretta come la precedente a portare il ragionamento sui limiti dello spazio/tempo, perché ora tutto è più libero, fluido, come il flusso di note che si perde nella musica minimalista di Steve Reich e poi si ricostruisce come in un movimento di clessidra. In quanto artisti di questa contemporaneità abbiamo il privilegio di scoprire nell’apparente disordine un ordine molto preciso. La mia ricerca è lì: verso quella nitidezza, pulizia, esattezza che esiste anche se non la conosci.

Diego Perrone tra i suoi lavori della personale al Macro (2022-23). Cortesia di Macro-Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Altri articoli dell'autore
Nella Fondazione Pino Pascali, sede anche dell’omonimo Archivio, un’installazione dell’artista romana presentata a Kassel dialoga con il grande murale esposto nella 58ma Biennale di Venezia
Il complesso universo dell’immaginifico artista fiammingo, affiancato dalla sua musa Stella Höttler, in una mostra nella Galleria Gaburro e in uno spettacolo al teatro Out Off di Milano
«Se si lavora con artisti viventi è necessario costruire un rapporto empatico, non solo valutare il progetto ma interpretarne i desideri, le ossessioni, i timori. Sono individui alla ricerca di sé e questo ha come prezzo l’incertezza», dice l’amministratore delegato e direttore di Palazzo Grassi-Punta della Dogana
Nel Palazzo delle Esposizioni la seconda edizione del festival che riporta l’attenzione sulle oltre quaranta realtà fondate nella capitale tra il 1666 e il 2016