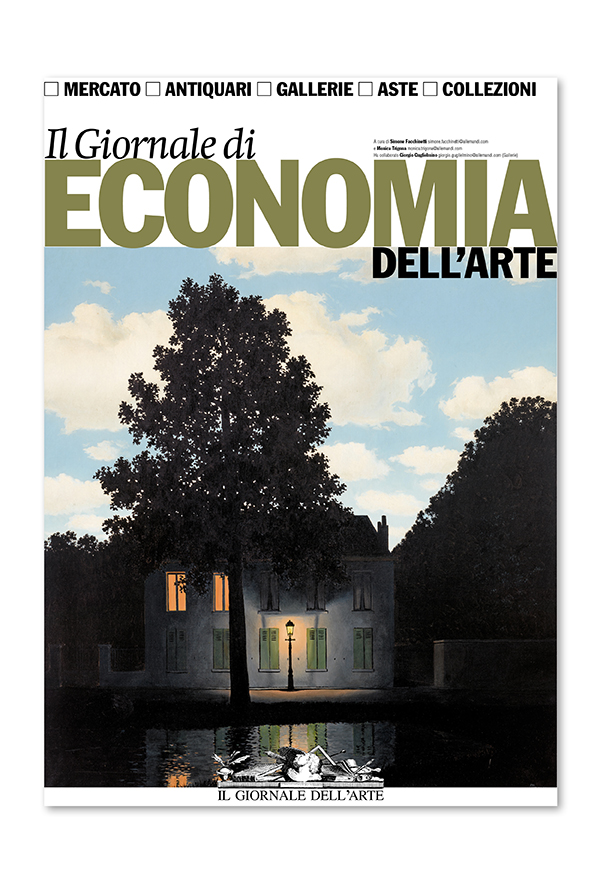Nato nel 1968, l’artista californiano ha realizzato un corpus di opere multimediali che esplorano nuove forme di creazione. In occasione della sua mostra «Howl» alla Galerie Eva Presenhuber di Zurigo dal 9 giugno al 22 luglio, parla della sua carriera, della sua visione e dei suoi progetti.
Qual è stato il suo primo shock estetico?
È una domanda molto interessante. I momenti che ricordiamo sono quelli che segnano una rottura, quando accade qualcosa di nuovo e stimolante. Uno dei valori essenziali dell’arte non è forse quello di sfidare il nostro senso della realtà e ciò che riteniamo stabile? Per molti versi, la vita è come una molecola di Dna fatta di incontri ed eventi diversi. Per me, vivere e creare sono due cose completamente intrecciate. Perché ricordiamo certe opere nella nostra vita? Possiamo dimenticare centinaia di mostre tutte uguali, ma se vediamo qualcosa che ci sorprende e ci attrae, si apre una nuova porta. È molto eccitante considerare la possibilità che l’arte possa esistere ovunque e possa essere creata da qualsiasi cosa.
Ha ammirato qualche artista o movimento in particolare?
Sono sempre stato molto interessato a Dada, Fluxus e all’Arte concettuale. Sono stati momenti in cui uomini e donne hanno davvero cercato di lavorare al di fuori del sistema e di creare nuove forme d’arte. L’arte del XX secolo consisteva spesso nella rottura del piano pittorico, nella decostruzione dell’immagine stessa. Ciò che conta per me è la creazione di nuovi sistemi, non distruggendo ciò che esiste, ma immaginando altre possibilità e definizioni dell’arte.
Il suo lavoro consiste in paesaggi multimediali immersivi creati utilizzando un’ampia gamma di media: film, suono, fotografia, scultura, performance, happening e installazioni site specific. Come lo definirebbe?
Ogni opera d’arte e ogni progetto è in qualche modo un’idea unica che crea il proprio viaggio. Mi piace il fatto che un’opera d’arte sia all’origine di un processo che ti porta in luoghi in cui non sei mai stato prima. Può metterti di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili e permetterti di sfidarli, di superarli. È l’energia della scoperta. Preferisco lavorare in modo polifonico, simultaneamente con diversi media.
Cerca di provocare una particolare sensazione nello spettatore, di renderlo consapevole?
Un’opera d’arte può produrre un’emozione solo quando c’è attrito tra essa e il suo pubblico. Se è semplicemente armoniosa, il visitatore si accontenta di guardarla, in modo voyeuristico, ma non viene realmente coinvolto. L’innesco emotivo esiste solo quando l’opera suscita una sensazione di discordia, producendo qualcosa di inaspettato, da cui emerge una nuova energia. È allora che l’esperienza dell’arte può toccarti e coinvolgerti. Sono sempre stato molto interessato all’idea di andare oltre l’immagine. Per generazioni siamo stati educati con le immagini, crescendo circondati da film e fotografie. Eppure, di fronte a tutti questi tipi di immagini, in un certo senso rimaniamo passivi. Giudichiamo le immagini, ci piacciono o non ci piacciono. Guardiamo la superficie: se ti piace il colore rosso, probabilmente ti piacerà la vernice rossa. Ma come si può «danzare» con un’idea o un concetto e diventare un tutt’uno con un’opera d’arte? Questo mi affascina e non credo ci sia una sola risposta.
Non c’è un modo giusto o sbagliato per farlo. Ogni opera d’arte può essere uno strumento da esplorare in modi diversi. Creo installazioni architettoniche, film, sculture che volano nell’aria, musica e suoni e messaggi digitali. Mi piace paragonare la creatività a un albero, con molti rami senza doverne scegliere uno specifico. Un artista non deve definirsi in base al mezzo che ha scelto; la creazione deve essere uno strumento per immaginare viaggi diversi, anche se tutte le opere di uno stesso autore sono interconnesse. Per esempio, i film di Jean-Luc Godard, che rappresentano un’intera vita dedicata al cinema, e i documentari e la fiction di Agnès Varda, sono tutti molto diversi. Ma sono legati tra loro perché condividono radici simili, domande comuni come: che cosa significa essere vivi? Come ci definiamo? Come ci muoviamo verso il futuro? Credo che l’individualità radicale sia la cosa più bella dell’arte. La creazione è più potente quando trasmette la voce di un individuo in modo molto distinto, e così facendo cattura la nostra attenzione. Questo è ciò che cerco di ottenere con la mia arte.
Qual è il suo modus operandi come artista?
Tutto inizia con la curiosità, con una sorta di scintilla che può far partire un viaggio. Spesso non si sa come arrivarci, e il fatto di non saperlo, questa vulnerabilità, è una parte essenziale del processo creativo. In tutto ciò che si cerca di creare, qualunque sia il mezzo, si incontrano sempre degli ostacoli. È questo che rende le cose interessanti perché, senza queste sfide, sarebbero noiose e senza vita. La curiosità è una forza motrice, un’energia, ma bisogna fidarsi del proprio impulso per andare avanti e trasformare quell’energia in un’opera d’arte.
Nel 1999 ha vinto il premio internazionale alla Biennale di Venezia con l’opera «Electric Earth». Nel 2009 ha installato un Padiglione sonoro nel giardino botanico di Inhotim in Brasile. Nel 2012 ha inaugurato ad Arles una commissione della Fondazione Luma intitolata «Altered Earth».
«Altered Earth» è probabilmente il lavoro più importante che ho realizzato in Francia. Il contesto era interessante perché la Fondazione Luma non esisteva ancora come edificio. Il lavoro è nato quindi da una conversazione con il paesaggio, la Camargue, una zona umida piuttosto surreale: il vento ulula in primavera, ci sono saline, paludi e un habitat naturale selvaggio. Mi sono chiesto: «Sarebbe possibile creare un’opera da questo paesaggio?». E ho iniziato a pensare a come affrontarlo. Quando pensiamo alla Land art, di solito immaginiamo opere fisiche. Mi sono detto: «E se creassi Land art usando immagini in movimento e suoni? E se prendessi la geografia della Camargue e la dividessi in pezzi per formare una griglia, ogni pezzo raccontando la propria storia?».
Ho trascorso circa un anno a filmare le quattro stagioni: ognuna di esse è diventata un’isola di storie diverse riprese in un paesaggio più ampio. Una volta terminate le riprese, ho creato un’installazione con numerosi schermi cinematografici e audio, che assomiglia a un gigantesco origami. Questa installazione labirintica è stata allestita nell’enorme spazio buio dell’ex fabbrica ferroviaria di Arles. Entrando, si aveva l’impressione di trovarsi al centro di un caleidoscopio paesaggistico, composto da elementi che vanno dal micro al macro, dalle canne che soffiano nel vento all’oceano violento della notte. Volevo distillare il paesaggio, creare una sorta di architettura liquida, uno spazio esperienziale in cui vagare. Il lavoro non è un documentario, ma piuttosto una sorta di interpretazione fittizia del paesaggio.
Nel 2013 ha organizzato «Station to Station»: per tre settimane un treno, concepito come una scultura di luce in movimento, ha trasmesso arte, musica e contenuti a un pubblico internazionale mentre viaggiava da New York a San Francisco. Nove fermate lungo il percorso hanno dato vita a una serie di eventi. «Station to Station» ha poi riunito oltre cento artisti al Barbican Centre di Londra nell’estate 2015. Sono stati realizzati anche un lungometraggio e un libro sul progetto. Che cosa la interessa della dimensione partecipativa e del lavoro su così vasta scala?
Alcuni dei progetti che realizzo cercano di spingere indietro la definizione di ciò che l’arte può essere e quali sono i suoi limiti. Cerco di immaginare nuove opzioni per far sì che l’arte diventi qualcosa di più ampio ed espansivo. Il modello artistico attuale è molto conservatore: entriamo in una sala climatizzata con illuminazione controllata per vedere una mostra che propone forme più o meno simili a quelle che già conosciamo. Dobbiamo cercare delle alternative. Un progetto come «Station to Station» consisteva nel creare qualcosa in loco. Composto da dodici vagoni, il treno ha percorso 4mila miglia attraverso il Nord America. Era una sorta di laboratorio nomade, una piattaforma mobile che permetteva ad artisti visivi, musicisti, danzatori e cineasti di creare in movimento.
Ci fermavamo in diverse stazioni, sia che si trattasse di grandi centri urbani come Chicago o New York, oppure di un piccolo luogo in mezzo al deserto, o addirittura di una fattoria. In ogni caso ci sono stati eventi. Per definizione, un evento coinvolge sia il pubblico sia l’artista, fondendoli in un’unica entità. Il progetto «Station to Station» si propone di uscire dal sistema artistico tradizionale, di lavorare direttamente con i creatori dando a questi uomini e donne uno strumento per concepire qualcosa di radicalmente nuovo. E questa esperienza dal vivo viene offerta al pubblico sul momento. Più la cultura si evolve in questa direzione, più si apriranno le nostre possibilità culturali e più l’umanità sperimenterà rivelazioni.
Dopo la sua retrospettiva del 2016 al MoCA di Los Angeles, lei ha portato a termine uno dei suoi progetti più ambiziosi, «Underwater Pavilions»: tre padiglioni subacquei installati sotto l’Oceano Pacifico, al largo della costa di Catalina Island, in California. Può parlarci di questo progetto?
Gli «Underwater Pavilion» erano sculture galleggianti realizzate in parte con specchi riflettenti, ma anche concepite come un aggregato di rocce grezze per consentire alla vita marina di colonizzarle. L’idea era di creare opere che i visitatori potessero raggiungere nuotando. Si trovavano a diverse altezze sotto la superficie dell’oceano, molto vicine e accessibili, oppure a una profondità maggiore. Il nostro laboratorio si è improvvisamente trasformato in un crocevia in cui un biologo e i progettisti di sottomarini per la ricerca oceanica si sono confrontati. Una delle cose che mi affascina dell’arte è la sua capacità di creare ponti, nuove connessioni. Tutti i miei progetti, in un modo o nell’altro, sono in grado di aprire una porta a un altro settore della conoscenza, a un gruppo di persone che altrimenti non si sarebbero mai interessate all’arte come la conosciamo.
Gli «Underwater Pavilion» sono stati allestiti vicino a un’isola isolata. Bisognava arrivarci in barca e poi indossare una muta, una maschera o una bombola. Sebbene l’isola fosse isolata, molte persone vi si recavano per viverla in prima persona. Questo lavoro era un modo per ricordarci che ci sono tante cose nel paesaggio con cui non siamo in contatto, da cui siamo disconnessi. Più ci muoviamo, più ci muoviamo velocemente nel mondo digitale, un mondo di schermi e superfici, più ci allontaniamo dal pianeta, dalla pietra e dall’acqua. Penso che oggi sia possibile vedere l’arte nel paesaggio in un modo radicalmente nuovo e fresco. Si tratta di guardare opere che suscitano la nostra curiosità e ci costringono a lasciare il rifugio delle nostre case e città, per esplorare l’ambiente in un modo che probabilmente non è mai stato fatto prima.
L’interazione delle sue opere con l’ambiente e il visitatore è un elemento ricorrente nel suo lavoro. La scultura «Mirage», ad esempio, una casa interamente ricoperta di specchi, è stata installata nel 2017 nel cuore del deserto californiano. È stata poi installata a Detroit, nel Michigan (2018), e a Gstaad, in Svizzera (2019-21). È una casa, una scultura in cui si può entrare? L’opera confonde i confini con il suo gioco di riflessi tra interno ed esterno.
Assolutamente sì. «Mirage» è un’opera vivente, un pezzo di tempo che si evolve in sincronia con voi e con me e nel quale potete camminare. Cambia continuamente: a volte si vede a chilometri di distanza, a volte scompare. Mi piace l’idea di un’opera d’arte itinerante. Quando ho creato «Mirage», stavo lavorando con il curatore Neville Wakefield alla biennale d’arte «Desert X» in California. Gli dissi che, una volta terminata l’opera, non ero sicuro che qualcuno l’avrebbe mai vista. Pensavo che solo poche persone ossessionate dalla Land art avrebbero voluto visitarla. Mi sbagliavo. Quello che non avevo previsto è che «Mirage» è una scultura nuda e vulnerabile: non si compra un biglietto, non c’è sicurezza, nessuno ti dà regole su che cosa puoi o non puoi fare.
Questo ha dato potere ai visitatori, permettendo loro di vivere quest’opera in modo singolare, quasi di esserne gli autori, ognuno in grado di vivere il proprio incontro con essa. Questo non sarebbe stato possibile se l’opera fosse stata installata in un parco di sculture appartenente a un museo o in una proprietà privata. In questo senso, «Mirage» mi ha insegnato molto. È stato interessante vederla dal vivo in luoghi diversi: prima in questo paesaggio roccioso del deserto, con il vento e il caldo; poi a Detroit, in uno spazio buio e surreale nel centro della città, un edificio non occupato da decenni; infine sulle Alpi, dove in inverno fa molto freddo, con il ghiaccio. Volevo che queste ambientazioni fossero diametralmente opposte tra loro.
Per il suo ultimo lavoro, «Howl», in mostra alla Galerie Eva Presenhuber di Zurigo, ha filmato una città dell’Ovest americano dove la vita dipende dall’estrazione di combustibili fossili. Il paesaggio desertico martellato dalle trivelle che perforano senza sosta è contrapposto ai movimenti di danza di giovani donne su un palco, a una banda di ottoni e alle testimonianze degli abitanti della città. Il film ci invita a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente e sulla necessità di modificare il nostro comportamento di fronte al cambiamento climatico. L’ha concepito come una metafora ecologica?
«Howl» ha richiesto più di tre anni di riprese e all’inizio il film non aveva alcuna struttura. Andavo in questa città isolata nel deserto e passavo semplicemente il tempo a filmare la terra e la gente del posto. A un certo punto ho accumulato così tante riprese che le direzioni possibili erano quasi troppe. Così mi sono allontanato dal film per otto mesi e, quando ci sono tornato, mi si è presentata una nuova direzione. Mi sono detto: «Perché non affrontare questo lavoro come musica piuttosto che come film? Riduciamo il linguaggio delle persone che abbiamo filmato a semplici parole e frasi. Lasciamo che il linguaggio diventi quasi un ritmo in questo paesaggio meccanizzato, che le parole e i pensieri si fondano con il rumore delle turbine petrolifere che pompano per tutta la notte».
Volevo creare una sorta di poesia per il XXI secolo su un paesaggio che sta scomparendo. Il titolo si riferisce a una famosa poesia di Allen Ginsberg. Ho sempre amato la parola «howl» (grido), la sua singolarità, la sua astrazione. «Howl» affronta le questioni ecologiche in modo molto sottile, ma non si trattava di fare un’opera d’arte didattica o un documentario. Volevo lasciare spazio all’interpretazione dello spettatore. Viviamo in un mondo pieno di messaggi, segnali e informazioni che a volte possono essere scoraggianti. Le informazioni sono diventate troppo abbondanti e troppo rapidamente diffuse. Realizzare quest’opera mi ha permesso di creare uno spazio che rallenta il tempo, il paesaggio, che permette a tutti di entrare, riflettere e interpretare, piuttosto che essere bombardati da messaggi. L’ensemble, presentato per la prima volta in occasione di questa mostra a Zurigo, è una sorta di sinfonia di media, una composizione di sculture, parole, suoni e immagini in movimento. Quando si entra in quest’opera, ci si trova improvvisamente immersi nelle idee che essa trasmette. Si diventa le idee, si vive e si respira attraverso l’arte. Non c’è separazione tra loro e te.
Come vede l’evoluzione del suo lavoro?
Non ho mai prestato molta attenzione al mio lavoro passato. Mi sveglio ogni mattina con la sensazione di non aver fatto nulla. La curiosità e il desiderio sono una fonte di energia che spinge a creare qualcosa di nuovo o ad andare oltre. Ho realizzato ben poco. C’è così tanto da fare e così poco tempo…
Quali sono i suoi prossimi progetti?
Al momento sto sviluppando un pezzo basato su una composizione vocale per trenta-cinquanta cantanti. Ci sto lavorando in sordina da diversi anni. È una collaborazione con la Los Angeles Master Chorale e comprenderà diversi elementi: un film, che potrebbe essere accompagnato da musica dal vivo, e un’installazione. Questo progetto su larga scala racconta la storia di individui che vivono in una società che si sta dirigendo verso un futuro astratto e sconosciuto. È un film narrativo, ma senza dialoghi, raccontato interamente attraverso la musica, il suono e le immagini.
Quale consiglio darebbe a un giovane artista?
Non avere paura del fallimento. È nel fallimento e nel crollo che spesso troviamo elementi nuovi per il nostro lavoro. Quello che vediamo nella società di oggi si basa per lo più su certezze ed è culturalmente conservatore. Le cose che ci toccano davvero, quelle che ricordiamo, quelle che risuonano, sono spesso nuove, dirompenti e inaspettate. Credo che per tutti noi la cultura sia una delle cose più importanti della nostra società. Ci eleva al di sopra del cibo sulla tavola, del tetto sopra la testa, dei bisogni fondamentali dell’essere umano. La cultura ci dà ossigeno per respirare, sognare, avere allucinazioni e pensare in modo nuovo. Non dobbiamo mai sottovalutarla. La cultura non è un lusso, è una necessità.

Alcuni still di «Howl» (2023), di Doug Aitken