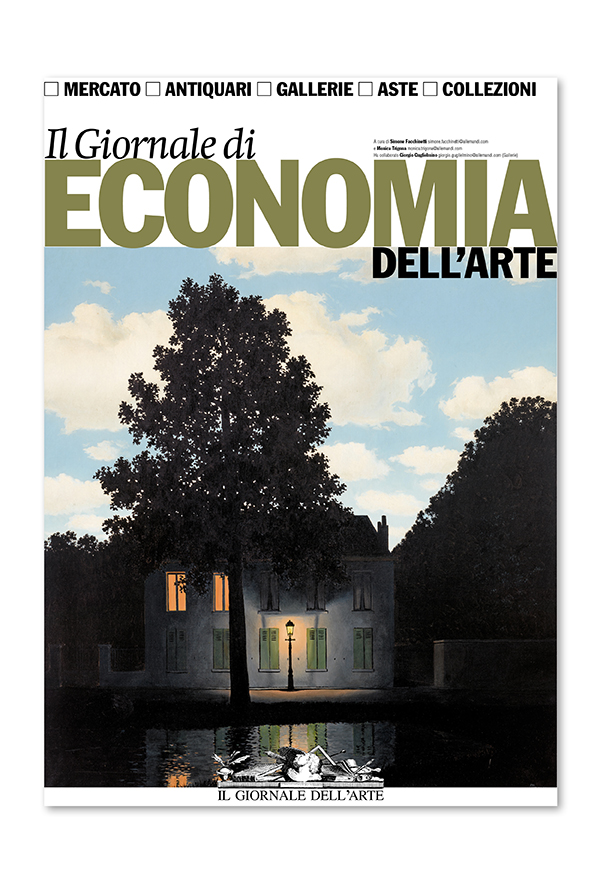Giorgio Bonsanti
Leggi i suoi articoliUn tempo lo stacco dei dipinti murali dalla parete era ritenuto il provvedimento migliore ai fini conservativi, anche se molti mettevano in guardia (già fin dai primi dell’Ottocento) dalla commerciabilità e dalle alienazioni rese possibili da quella soluzione. Le distruzioni della seconda guerra mondiale, nel timore di un futuro conflitto atomico, facevano sì che in molti propugnassero gli stacchi; Roberto Longhi sosteneva lo stacco preventivo dei grandi cicli di affreschi, a cominciare dalla Leggenda della Croce di Piero della Francesca ad Arezzo.
Altri, come il grande soprintendente fiorentino Ugo Procacci, erano convinti che l’affresco avesse per sua natura una vita limitata, che Procacci valutava in cinquecento anni, dopodiché sarebbe collassato in mancanza dello stacco. L’alluvione di Firenze costrinse a estese campagne di stacchi eseguite di assoluta urgenza, e in quel caso si trattava davvero di salvare il possibile. Domanda: e dopo, di questi chilometri quadrati di affreschi staccati, cosa ne facciamo?
Impensabile ricollocarli da dove provenivano, così si giudicava, se proprio la loro ubicazione era all’origine del male; e allora affollavano i depositi, nell’ipotesi lungamente considerata della creazione di grandi musei di affreschi staccati (del resto ripetutamente esposti in mostre, in Italia e all’estero). Qualche ricollocazione era stata tentata, ma sporadicamente. E qui non posso evitare di parlare in prima persona. Fra i compiti assegnatimi dal soprintendente Luciano Berti al mio ritorno a Firenze dopo cinque anni nella Soprintendenza di Modena (dove del resto avevo fatto ricollocare gli affreschi Fiordibelli di Niccolò dell’Abate, a Reggio), fu la direzione dell’Ufficio Restauri, una struttura contabile-amministrativa.
Con le mie due collaboratrici, cui si aggiunse dopo un paio d’anni la storica dell’arte Magnolia Scudieri, conducemmo dapprima una ricognizione dei depositi, e dopo detti avvio al progetto di ricollocazioni, che riguardava soprattutto gli affreschi staccati dai chiostri di chiese e conventi. Non fu una decisione presa a cuor leggero, né le conoscenze tecniche e le esperienze del 1980 erano quelle d’oggi.
Ma le considerazioni che svolsi erano più o meno queste: che i depositi non erano attrezzati e dunque il degrado continuava; che la mancata accessibilità degli affreschi, ammonticchiati uno sull’altro, ne impediva il controllo continuato; che non si intravedevano soluzioni diverse e accettabili; che un’opera non fruita da nessuno perdeva senso e identità. Le ricollocazioni ebbero inizio (per prime, il Chiostro Verde di Santa Maria Novella e il Chiostro dei Voti alla SS. Annunziata); e proseguirono a opera del’Ufficio Restauri, alla fine diretto da Magnolia Scudieri, anche dopo che io ebbi lasciato la Soprintendenza per divenire soprintendente dell’Opificio (1988).
Non mancarono posizioni contrarie. Cesare Brandi, non l’ultimo venuto, scrisse sul «Corriere della Sera» un articolo (1983) parlando di una «sciagurata sistemazione»; gli affreschi stavano all’aperto «a finire di farsi deteriorare». Propugnava comunque la chiusura del chiostro con vetrate; praticamente impossibili da realizzare su arcate con base di cinque metri, e non è affatto detto che il rimedio, alterando il microclima, non sarebbe stato peggiore del male. A significare quanto fosse partecipata la discussione, un articolo sulla questione (con al suo interno un’intervista a me) uscì addirittura nel «Wall Street Journal». Di questo e altri argomenti si è discusso in un recente convegno (24-25 ottobre) a Santa Maria Novella, grande chiesa-convento domenicana (ma oggi proprietà del Fec-Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno), organizzato dall’architetto Francesco Sgambelluri.
A chi mi domandasse se ancor oggi farei la stessa scelta, dovrei rispondere di sì; anche se è sempre più difficile mantenere fiducia nella reale possibilità di esercitare azioni di conservazione preventiva e manutenzione programmata, le due condizioni essenziali per completare il ciclo conservativo. Sarei sostenuto dall’apprezzamento che la mia azione riscosse fra persone del mestiere, fra cui un critico attento come Bruno Zanardi; che su «Il Giornale dell’Arte» mi riconobbe di avere dieci anni prima «indirizzato questa politica di ricollocazione di affreschi strappati», concludendo «onore e merito a chi questo spinoso problema ha voluto accollarsi»; non certo «imperturbabilmente», come aveva scritto Brandi, bensì in mezzo a mille dubbi e incertezze. Ma alla fine decidendo come ho raccontato.

Un momento della ricollocazione degli affreschi quattrocenteschi del Chiostro Verde di Santa Maria Novella a Firenze nel 1980
Altri articoli dell'autore
Aperto per restauri • A un anno dall’inaugurazione del museo, nella nuova sede di Palazzo Cavalli si è tenuto un convegno rivelatosi occasione interessante e piacevole per presentare un’ampia casistica di interventi conservativi infrequenti
Orietta Rossi Pinelli ripercorre le principali tappe di come sono cambiate le regole dalla Carta di Atene del 1931 ad oggi
Operatività, ricerca e didattica hanno improntato l’attività dell’insigne «ambasciatore» del restauro italiano, per quasi quarant’anni attivo all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, di cui è stato soprintendente per dieci anni
Tra i tanti interventi del convegno tenutosi a Roma per i sessant’anni della brandiana «Teoria del Restauro», particolarmente lucido e intelligente quello dell’archeologa Licia Vlad Borrelli, 102 anni